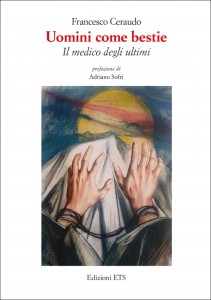La “mela marcia” Recensione al libro Uomini come bestie. Il medico degli ultimi di Francesco Ceraudo
gen 20th, 2020 | Di Thomas Munzner | Categoria: Recensioni
di William Frediani (*)
Sono entrato in contatto con Uomini come bestie1 per puro caso, durante un mio intervento sul carcere di fronte a una platea di donne e uomini impegnati nel volontariato2 . Tra i presenti, un signore barbuto ha preso la parola, in modo caustico e sferzante contro il sistema penitenziario, e ho capito subito che c’era qualcosa di inconsueto rispetto al solito. Riusciva a vedere il carcere con gli occhi del detenuto, avendolo introiettato dal di dentro. Non c’era solamente lo spirito, spesso autocelebrativo, del dedicarsi agli altri tipico del volontario. C’era qualcosa di più, c’era una compartecipazione sentita e naturale alla vita del prigioniero. Il giorno seguente, negli stessi locali, toccava a questo signore presentare il suo libro, e lo fece mettendo in piedi una critica al sistemacarcere rigorosa, radicale, feroce. Così ho conosciuto, anzi ritrovato, Francesco Ceraudo. Era il direttore del centro clinico del carcere Don Bosco quando mi ci trasferii per un semestre nel 2004, prima della mia promozione nei circuiti speciali. Non credo di aver avuto rapporti con lui in quei mesi. Non me lo ricordo. Come un razzista vede gli uomini di colore tutti uguali e, pur avendo parlato con uno di loro, assolutamente non ne ricorda, appena voltatosi, la fisionomia, così era per me. Guardie, medici, direttori, educatori: tutti avevano la stessa maschera, tutti agivano di concerto per mantenere in piedi il distruttivo sistema securitario della prigione. Ma non erano loro ad essere tutti uguali, ero io che, per puro istinto difensivo, mi ero in qualche modo schermato. Molti miei compagni “pisani” di detenzione mi parlavano bene di Ceraudo e del direttore Vittorio Cerri. Ne ero turbato. Pensavo che il sistema li avesse talmente piegati da diventare amanti del loro carceriere. Non riuscivo a capacitarmi del grado di prostrazione che l’apparato poteva ottenere. Erano, per me, vittime della sindrome di Stoccolma. Che forse potevo sbagliarmi, me ne accorsi quando fui trasferito nella sezione Elevato Indice di Vigilanza di Spoleto. Lì conobbi detenuti che erano stati curati al centro clinico del Don Bosco. A Pisa si sta bene, mi dicevano. No, rispondevo, a Pisa si stava male. Acqua scarsa, fatiscenza, palestra chiusa, affollamento, sporcizia ovunque e tanto chiasso. Ma non era per l’ambiente che desideravano Pisa. Era per le persone. Là, se stai male, te lo riconoscono, e giù a snocciolare una serie di nomi di detenuti malati che erano stati giudicati, proprio al centro clinico del Don Bosco, “incompatibili” col carcere.
1 Il libro è stampato dalle Edizioni ETS di Pisa (2019). 2 “Il carcere non deve arrestare la vita”, ciclo di conferenze e dibattiti tenutosi a Pisa dal 9 al 14 dicembre 2019, patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune e dalla Provincia di Pisa, dal Servizio Sanitario della Toscana, dalla Società della Salute della Toscana e dalla Camera Penale di Pisa “Antonio Cristiani”.
Non erano i detenuti di Pisa a essere morbidi con il sistema, pensai allora. Era radio carcere che aveva diffuso la voce secondo cui sotto la torre pendente era tutta un’altra storia. C’erano là brandelli di speranza di comprensione che altrove erano negati aprioristicamente. Scrivere oggi, a distanza di anni, di Francesco Ceraudo non è facile. Non l’avrei mai fatto prima, per pregiudizio. Un pregiudizio – ritengo – sano, cautelativo, di appartenenza al mondo dei detenuti. Eppure, il suo Uomini come bestie è un libro oggettivo, tanto reale da essere partigiano. L’autore sta dichiaratamente dalla parte dei detenuti, uomini e donne rinchiusi come animali nelle gabbie di uno zoo ingiusto. Non c’è nessun preconcetto, nessun tabù nella sua descrizione. Nessun falso pietismo, nessuna richiesta di assoluzione per la brutalità del sistema, nessuna colpevolizzazione delle vittime incarcerate. Niente, se non compartecipazione al dolore e alla rabbia. La stessa rabbia e lo stesso dolore vissuti dal prigioniero. Posso finalmente togliermi, dunque, la maschera che mi ha schermato, posso abbattere l’ultimo pregiudizio. Il primo giorno che ho avuto in mano il suo libro, scorrendo l’Indice, ho visto che c’era un capitolo sul “caso Cucchi”, il giovane geometra romano, incensurato, massacrato dai carabinieri e giustiziato in carcere dall’inazione deliberata dei medici penitenziari. La posizione di Ceraudo su questa vicenda costituisce una cartina tornasole sulla sua integrità. Non vi si trova nessuna difesa corporativa dei medici, al contrario. Vi è un duro atto d’accusa verso i colleghi, corresponsabili insieme ai carabinieri dell’omicidio di Cucchi. Tutti, nessuno escluso. E non si limita allo sdegno per i colleghi, ma esprime parole di estrema comprensione e profonda umanità per la vittima.
Prova di onestà intellettuale ampiamente superata, dunque. Se ne ha conferma quando affronta il caso Serantini e la vicenda del dottor Alberto Mammoli. Franco Serantini era un giovane anarchico massacrato a colpi di scarponi e di calci di fucile dal Reparto Celere durante una manifestazione antifascista a Pisa nel 1972. Semicosciente, fu sbattuto in caserma e poi in prigione. Dopo un imperdonabile ritardo, il dottor Mammoli si decise a visitarlo. Si limitò a descrivere superficialmente qualche livido e lo rimandò in cella con la prescrizione della sola borsa del ghiaccio. Serantini stava morendo. Aveva gravissime fratture al cranio, lesioni polmonari e renali, ossa rotte. Non riusciva a muovere la testa. Ma il medico finse di non accorgersi di niente. Franco spirò dopo ore di atroce agonia. Il 30 marzo del 1977, un gruppo armato di matrice anarchica gambizzò il dottor Mammoli ritenendolo, a ragione, corresponsabile dell’omicidio di Serantini. Francesco Ceraudo entrò a lavorare al Don Bosco proprio in sostituzione del dottor Mammoli. Il terreno è delicato. Come ha deciso di descrivere gli eventi convulsi del massacro del giovane anarchico e del suo tormento mortale? Le pagine che l’Autore vi dedica sono di assoluta empatia nei confronti di Franco, senza risparmiarsi nella critica secca dell’azione del personale medico penitenziario. Quanto all’attentato subito da Mammoli, infine, si limita a riportarlo come semplice cronistoria, senza il minimo afflato derivante da una qualche solidarietà di categoria. Ceraudo non è anarchico, non è rivoluzionario, non nutre alcuna simpatia per il movimento armato degli anni Settanta. Ma, mi pare, è estremamente combattivo nel pretendere assoluta libertà di giudizio, incurante di qualsivoglia ritorsione. E non si nasconde: la spinta solidaristica che lo muove è a senso unico, verso i detenuti, non verso l’istituzione. Non è un ex detenuto di cui stiamo parlando. È un ex uomo del penitenziario. Come tale deve “rendere merito” a tutti i direttori del carcere Don Bosco e anche alla Polizia Penitenziaria, ricordandone lo spirito di sacrificio e la professionalità. Lo fa in poche righe d’avvio in modo che ricorda piuttosto un atto d’ufficio. In tutto il libro gli uomini d’apparato compaiono molto spesso come ostacoli alla salute del prigioniero, barriere all’instaurazione di atteggiamenti comprensivi, mai come aiuto. E non si troverà in nessun luogo una riga di piaggeria verso le istituzioni, al contrario. Solo critica intransigente al sistema “surreale, primitivo e punitivo”3 , caratterizzata da quella radicalità che alberga in uno spirito libero e nell’onestà intellettuale. Ogni espressione di empatia e solidarietà è rivolta sempre e soltanto ai prigionieri, con cui si relaziona professionalmente coi mezzi dell’ascolto e del rispetto aperto.
Uomini come bestie è un pugno nello stomaco. Ed è molto più forte perché non proviene dalla voce della vittima, ma da un uomo di sistema. Appena ho cominciato a studiare questo libro, ho pensato che soltanto per l’intensa Prefazione di Adriano Sofri valesse la pena possederlo. Ma questo era facilmente prevedibile. Sofri ha inciso in carcere nella carne e nello stomaco e maneggia le parole e i concetti con una padronanza invidiabile. Proseguendo la lettura, pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, se ne rimane fortemente percossi. Il mio libro-indagine sul carcere, scritto dalla visuale della popolazione detenuta, è in molti punti sovrapponibile, segno che anche dall’altra parte è possibile comprendere. E questo crea sgomento. Se c’è riuscito Ceraudo, perché non possono farlo anche gli altri? Perché le voci critiche provenienti dal personale carcerario sono un pugno di mosche bianche nella storia del nostro Paese? Perché il detenuto deve trovarsi quotidianamente sottoposto a procedure e meccaniche che lo riducono a mera cosa da gestire, senza mai una resistenza compartecipata da parte dello staff dell’istituzione totale? Eppure Uomini come bestie è qui a dimostrare che è possibile. E non perché Francesco Ceraudo sia un diverso o un eroe. Qualcosa in lui deve essere scattato. Qualcosa di umano, qualcosa di civile, qualcosa che ha a che vedere con l’educazione alla verità e al senso di giustizia.
Non soltanto Ceraudo descrive il carcere in modo crudo e oggettivo. Lo fa senza mai usurpare la voce del detenuto, senza mai cadere nel dispositivo che Foucault e Deleuze definiscono l’infamia del parlare per altri.
3 Tutte le citazioni non altrimenti specificate in nota sono tratte da Uomini come bestie.
Non pretende mai di arrogarsi il diritto di dire cosa i detenuti pensano o vogliono. Li cita, gli dà la parola, ma con grande rispetto non si sostituisce mai a loro. Li descrive con attenzione certosina, con sguardo medico. È sgomento nel vederli camminare avanti e indietro in uno stretto cortile di cemento armato. Vi riconosce certamente le stereotipie degli animali in gabbia. Stereotipie che sono sintomo di un profondo e radicato malessere. Quando una tigre in uno zoo mostra comportamenti stereotipati, interviene una larga schiera di veterinari, ambientalisti, animalisti, politici, volontari, giornalisti a chiedere all’unisono condizioni più umane per l’animale. Ma quando questo capita ai detenuti (attenzione: a tutti i detenuti), dove sono i medici, i politici, gli umanisti, i difensori dei diritti dell’uomo a domandare un miglioramento delle condizioni di vita dei prigionieri con standard di vita salubre almeno parificata a quella di ogni altro essere umano?
Non è un eroe, ho detto. Era soltanto un medico, senza esperienza, catapultato giovanissimo in carcere a prestare soccorso agli ultimi della terra. Ancora fresco di incarico, scoprì violenze e tangenti nel carcere di Pisa. Detenuti costretti a pagare per ottenere un lavoro o addirittura per fare l’ora d’aria, pestaggi, corruttele varie imposte dai massimi livelli. Fu il suo battesimo di fuoco. Il suo istinto primario fu quello di auto-tutelarsi, di mantenersi separato dal sistema infausto in cui si trovava a operare evitando ogni possibile collusione. Era stato minacciato di non impicciarsi. È facile immaginarsi come questo giovane medico fosse pervaso dalla paura. Arrivò a temere che il personale penitenziario potesse attentare alla sua persona. Si spinse fino a indossare il giubbotto antiproiettile e a non portare la borsa in carcere perché le guardie – riteneva – avrebbero potuto metterci dentro droga per ottenere il suo licenziamento. Non denunciò subito, il giovane Ceraudo. Ma le sue proteste non passarono indenni. Subì rappresaglie professionali e per miracolo fu soltanto declassato. Non era un ribelle, non ancora. Erano lontani i tempi in cui si sarebbe incatenato ai cancelli della prigione in difesa del diritto alla salute dei detenuti. La sola cosa a cui teneva allora era salvaguardare la sua onestà e integrità umana e professionale, oltre che la pelle. Alla fine parlò. Non coi magistrati, ma con un politico importante, un Sottosegretario. Inesperto e impaurito come un Sancho Panza, non sapeva ancora come agire. Andava a tentoni, sperando che qualcuno smuovesse le cose. Ed è quello che avvenne. Si attivarono le indagini e emerse il finimondo: il personale vendeva droga ai detenuti, facendola pagare a peso d’oro; conti in banca dei dipendenti del carcere che si gonfiavano; chi non pagava era fatto massacrare. Ci furono arresti ai massimi livelli. Al Don Bosco, tutti sapevano ciò che vi avveniva, tutti erano coscienti che era un girone infernale, luogo di connivenze, gregarismo e omertà. Ceraudo parla di “mele marce” da strappare perché le cose possano funzionare meglio. Ma qui occorrerebbe fare una torsione di coscienza. Il nostro dottore fu l’unico che trovò il coraggio di denunciare. E non ricevette alcun tipo di solidarietà da parte di tutto il personale penitenziario, fatta eccezione per una sola guardia che tuttavia non si espose. A ben vedere, la sola “mela marcia” era lui, Francesco Ceraudo, in un frutteto che prosperava sulla violenza e la corruzione. Da allora Ceraudo smise i panni del Sancho Panza e prese le cose di petto, in modo intransigente e irremovibile. Decise che intorno a sé non ci sarebbe più stato alcun genere di ingiustizia dispotica. La sua incorruttibilità ampliò a dismisura la credibilità della sua persona. Si era conquistato potere sul campo, diventando la personificazione di un’assoluta legalità. Il sistema non aveva più mano libera per sporchi traffici. Si sapeva, ora, che questo dannato medico aveva amicizie nei luoghi che contano e da solo aveva smosso mezza Italia facendo fuori direttore, comandante e guardie. Fu a quel tempo che, credo in modo non preordinato e involontario, la sua figura assunse una posizione differente rispetto a ciò che siamo comunemente abituati a riscontrare in una galera: era chiaro che non gli si poteva fare sotto il naso e che qualsiasi azione lesiva nei confronti dei detenuti avrebbe avuto serie conseguenze.
Non ha mai abbandonato la barca. Avrebbe potuto mollare per dedicarsi a denunciare la barbarie istituzionale, ma non l’ha fatto. È rimasto lì, al suo posto, a lottare contro i muri di gomma dell’apparato, “come un cane che abbaia alla luna” inascoltato, che, chissà perché, continua ad abbaiare. Il libro è venuto dopo, nell’età della pensione. Perché solo con distacco si possono scrivere denunce così drastiche. Perché solo con distacco si può rivisitare la propria parabola professionale e ammettere di aver dedicato la vita a uno slancio di umanità in un luogo repellente a qualsiasi forma di comprensione e altruismo. C’è molto di melanconico in tutto questo. Come quelle storie di professori che si siedono per la prima volta alla cattedra carichi di dedizione e di speranze di cambiamento, salvo poi arrivare alla pensione portandosi dietro qualche ricordo di umanità e una vita di dolorose frustrazioni, consci del fatto che la scuola non è cambiata di una virgola, se non per i molti aspetti in cui è peggiorata. Oggi Ceraudo può permettersi di non nascondere neppure la nobile aspirazione al superamento del carcere. Ma è stato, ed è, uomo d’azione e come tale non ha mai rinunciato a battersi per un carcere non punitivo, non lesivo, addirittura dialogico. Il suo pensiero può essere compensato in questa frase: le validissime chiacchiere sull’abolizione del carcere non aiutano i prigionieri a vivere meglio.
Francesco Ceraudo conosce bene quello di cui parla. Il carcere – dice instancabilmente – è una “tortura ambientale”, da cui non si esce se non minati fisicamente, psicologicamente e socialmente. In questa Bolgia, che conduce alla “decomposizione dell’essere umano”, non sono possibili né la tutela dei diritti del detenuto, né i doveri di solidarietà dell’istituzione. È il non luogo per eccellenza, la torsione dello spazio-tempo, un porto franco senza protezione dall’arbitrio. L’ambizione di ricevere in istituto un uomo o una donna sani e di restituirli alla libertà in salute, in pieno benessere psichico e socialmente integrati è pura e vacua utopia. Ma l’Autore non ha mai smesso di essere un feroce utopista. L’alternativa sarebbe – e nei fatti è – il baratro, la sopraffazione, l’abbandono dell’Uomo nelle mani della stringente logica securitaria e distruttiva degli organi penitenziari dello Stato. Nelle pagine di Uomini come bestie troviamo parole toccanti sull’infantilizzazione dei detenuti, sulla loro “mutilazione” forzata, sugli effetti antisociali della prigionia, sulle conseguenze di “atomizzazione e di frammentazione sociale” che comporta l’esistenza stessa del penitenziario. Constatare che il carcere è “privo di qualsiasi umanità”, che è “barbarie senza alcun contenuto pedagogico, curativo, rieducativo”, che marcia esclusivamente tra “costrizioni e privazioni, obblighi e divieti continui e laceranti”, non è bastato a farlo arrendere. Sapeva di perdere, ma ha giocato fino alla fine. È qui, in questo terribile tormento, che si innesta l’essere medico. La cultura medica proposta da Ceraudo è “solidale con la storia dell’uomo detenuto, al di là di qualsiasi pregiudizio derivato dalla colpa commessa”. Nella lettura, si respira la sua totale adesione alla Risoluzione di Ouagadougou del 1991 nella quale si afferma che lo stato di salute dei detenuti deve essere prevalente su ogni altra considerazione, incluse quelle relative alla sicurezza, all’ordine e alla disciplina. Si respira l’adesione alla Dichiarazione di Caracas del 1998 che promuove tolleranza, dialogo e rispetto per la differenza, riconoscendo ai detenuti la titolarità di diritti inalienabili.
In origine presenza meramente caritatevole, ammesso poi per interventi d’urgenza, spesso soltanto terminali, pian piano il medico penitenziario diventa un membro dello staff carcerario, inserito con funzioni custodiali e partecipe della macchina violenta della reclusione: “Al medico si chiede di partecipare all’osservazione della personalità più che alla cura di possibili malattie”. È l’odiosa analisi clinica del delinquente descritta con parole di fuoco da Michel Faucault4 , che serve più che a controllare la popolazione detenuta, a sorvegliare e punire le classi sociali svantaggiate ancora a piede libero, quelle classi sociali che per sopravvivere difficilmente possono mantenersi all’interno degli stretti binari penali imposti alla società. Non si illude, Francesco Ceraudo, che il carcere sia per tutti. Non si illude che i detenuti siano lo specchio della società. La democrazia della reclusione è una falsa coscienza che non supera l’esame sociologico. La prigione ha profonde radici sociali e funzioni di dominio classista sui più deboli: Provengono – scrive – quasi tutti dagli stessi strati sociali, quelli più poveri. Prevalgono i poveri diavoli,
4 Foucault M., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, XVI ed., Torino, 2010, p. 272.
i cosiddetti “cani senza collare”, tutti appartenenti agli strati sociali più deboli, tirati su sui marciapiedi e nei sobborghi delle città. Sono quelli che si sentono sempre più isolati e che vengono visti come i vinti, gli sconfitti, i ribelli senza speranza… Persone che vivono uno stato di svantaggio, disagio o marginalità. No, grida Ceraudo, il medico penitenziario non deve avere alcuna funzione securitaria. Il medico deve certo curare le malattie, ma deve soprattutto agire contro i “rischi evidenti legati ad ambienti sicuramente insalubri e alle malattie tipiche della povertà e dell’emarginazione”. Il medico penitenziario dovrebbe focalizzare il suo lavoro verso un unico grande obiettivo: combattere contro la lordura degli istituti, contro i loro ambienti piccoli e malsani, contro le procedure annichilenti, contro l’architettura afflittiva, contro il rancio scadente, contro l’endemica mancanza di aria, di luce, di calore, di acqua, di senso di sicurezza. In definitiva, questo Don Chisciotte, questo antieroe che si scaglia contro i mulini a vento di un apparato immodificabile, combatte contro il carcere così com’è. Di più, combatte contro il carcere che adempie perfettamente alle funzioni per cui è stato progettato, alle quali non può e non intende rinunciare. Scrive, infatti, la sociologa Francesca Vianello, parlando delle condizioni inaccettabili di vita (e di morte5 ) del penitenziario: non bisogna parlare di fallimento; contrariamente a quanto si pensa, il sistema è straordinariamente efficiente nell’assolvere le sue reali funzioni e nel perseguire i suoi specifici obiettivi che non sono, però, l’umanizzazione della pena e la rieducazione del condannato, ma l’isolamento dei membri recalcitranti e non ancora socializzati alla disciplina del lavoro funzionale all’emergente ordine sociale capitalista e la loro riprogrammazione come membri di un proletariato socialmente affidabile e sicuro.6 Umanizzazione della pena e rieducazione sono, pertanto, elementi accessori. Che siano garantiti o meno non cambiano la reale efficienza della prigione.
Un’intera vita trascorsa a proporre un’inversione radicale del comportamento del sistema senza ottenere altro che frustrazioni. Le tristi condizioni in cui versa la casa circondariale Don Bosco sono la dimostrazione che l’apparato è immutabile. Foucault diceva che la storia della prigione è fin dall’origine la storia di una riforma, parole fin troppo educate per dire che il carcere è irriformabile. Eppure il Don Chisciotte non ha abbandonato la trincea. Al contrario le sue posizioni si sono spostate su un terreno di radicale denuncia. Oggi, in pensione, ha potuto fare un bilancio ragionato che è molto più che un intenso atto d’accusa, è una condanna senza possibilità di appello. È ormai sotto gli occhi di tutti questa drammatica, violenta realtà carceraria.
5 La morte in carcere ha un che di liberatorio. Dal 2000 al 2018 sono avvenuti 2874 decessi, dei quali 1053 per suicidio. Ben più di un detenuto su tre muore togliendosi la vita. Esiste al mondo un altro luogo in cui un terzo di umanità scompare auto-infliggendosi la morte?
6 Vianello F., Il carcere. Sociologia del penitenziario, Carocci editore, Roma, 2012, p. 20.
E in risposta? In risposta di montano letti a castello in doppia fila, a rasentare il soffitto; si occupano con luridi materassi le aule scolastiche, le palestre, gli spazi sociali e ricreativi (ormai invivibili) e perfino i corridoi. Come medico penitenziario, ha fatto suo il pensiero per cui occorre svincolarsi dall’onnipotenza e onniscenza della Custodia, senza mai – per dirla con le parole di un ex detenuto politico di nome Sandro Pertini – “subordinarsi al disegno di asservimento e repressione” penitenziario. La medicina propugnata rifugge “il confessionalismo, l’autoreferenzialità e l’autoritarismo”. Il bilancio che Francesco Ceraudo fa della sua vita da medico dentro è piuttosto una diagnosi: “la carcerazione è essa stessa una malattia, e severissima”. Più oltre: “Il carcere, anche il più riformato, produce in varie forme e secondo gradualità differenti sofferenza e sofferenti, malattie e malati”.
Chi è, dunque, l’Autore di Uomini come bestie, l’ex medico della casa circondariale di Pisa? È, in primis, un intransigente. Quando scrive che la prigione supera “ogni limite di tolleranza”, prende posizione chiara, divenendo intollerante verso un’istituzione intollerabile. È uno schierato dalla parte dei prigionieri, senza fraintendimenti. Non solo dei più deboli (le molte centinaia di detenuti handicappati “non dovrebbero assolutamente stare in carcere”), ma di tutte le persone rinchiuse: Non mi è mai capitato, ma se mai mi fossi trovato nella particolare circostanza di un detenuto che tentava l’evasione, credo che non avrei dato l’allarme. Non chiamatela complicità, per favore. Pensateci. È come trovarsi, da Medico, in un campo di battaglia, ma non distinguete fra i feriti […]. L’uomo non è, e non può essere una bestia da domare, un bersaglio eventuale da colpire. È un categorico lapidario. I prigionieri soffrono. Soffrono tutti, indiscriminatamente, al di là del reato specifico: Quando mi trovo davanti a un detenuto non ho pregiudizi di sorta, ma penso a lui come a un uomo che si è venuto a trovare in una situazione sfavorevole, in una circostanza avversa. Ho avvertito sempre nei confronti della popolazione detenuta un profondo rispetto, qualunque fosse la circostanza contingente. È un lettore di Goffman e conosce bene la categoria dell’istituzione totale. Per questo non risparmia, nella trattazione, un affondo anche contro le altre istituzioni in cui la società rinchiude i disagiati, i reietti, gli ultimi, siano esse i manicomi sotto falso nome o i Centri di Accoglienza per stranieri, vere e proprie “nuove galere arbitrarie”. È un sofferente. Scrive senza fraintendimenti che il carcere, istituzione che disumanizza e peggiora sia fisicamente che psicologicamente, in definitiva, è malattia e insieme malato esso stesso […]. Un carcere inutile che non riesce a realizzare la finalità che la Costituzione gli assegna: la rieducazione del condannato. Un carcere vendicativo, la forma peggiore per espletare la sua funzione istituzionale, di una vendetta che modifica tutto: il tuo essere, il tuo sorriso, i tuoi pensieri, il modo di comunicare, di amare, di credere, di sperare, di sognare. È un visionario. Immagina un mondo senza pena di morte, senza ergastolo, con larghissima diffusione delle pene alternative. Immagina il diritto all’affettività e alla sessualità dei prigionieri. È cosciente che i malati (tutti i malati, inclusi quelli detenuti) hanno bisogno di ambienti spaziosi, luminosi e salubri, e di aria pulita. Non è un illuso, ma non vuole rinunciare a immaginare che tutto questo sia un giorno possibile. È, infatti, un sognatore. E non smette di sognare nonostante l’impossibilità di superare l’ottusa irragionevolezza delle ragioni di custodia e di sicurezza. Il lavoro in carcere gli ha dimostrato che la salute non è la cosa più importante per un malato. Perché il malato, prima di essere un paziente è un uomo: il bisogno più vitale è pertanto la libertà. Quasi nessun medico la pensa in questo modo. Ma il contatto coi prigionieri gli ha aperto un nuovo modo di comprendere la vita. Sa bene, per averlo visto migliaia di volte, quanto distruttivo sia l’impatto di una persona con la reclusione. I nuovi giunti sono rinchiusi nel reparto Isolamento, la sezione più dura di tutto il sistema carcerario. E questo non perché l’esperienza abbia dimostrato che sia una procedura utile al sistema o al prigioniero. Si fa passare chiunque sotto le forche caudine dell’isolamento perché è sempre stato così, fin dalle origini delle prime carceri moderne, perché all’epoca si riteneva che questo servisse ad annullare ogni resistenza della recluta, a ridurre l’uomo e la donna alla docilità, all’impotenza, all’annientamento. Lo scopo è piegare, annullare, mortificare. Ma Ceraudo non è uomo da farsi sopraffare dalla consuetudine. Immagina un Polo di Accoglienza per i nuovi giunti, che riduca i traumi della prigionizzazione, attraverso informazioni, colloqui cadenzati, ascolto e ambienti accoglienti. Tutto lettera morta. Una battaglia persa, come tutte le altre, del resto. Ma è questa l’essenza di un sognatore e di un coraggioso utopista: dar battaglia anche se non c’è alcuna possibilità di vittoria.
Pisa, Natale 2019. (*) William Frediani, autore di “Un universo di acciaio e cemento. Vita quotidiana nell’istituzione totale carceraria”, Sensibili alle Foglie, 2018.