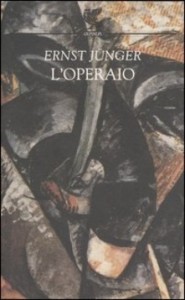L’Autonomia Operaia di Ernst Jünger
mag 19th, 2020 | Di Thomas Munzner | Categoria: Cultura e società
I
La borghesia prepara la Mobilitazione Totale. Produce ciò che la seppellirà. Il capitalismo impianta un nuovo spazio, dal quale l’Arbeiter spiccherà il salto verso un nuovo Tipo umano, verso un nuovo Impero planetario: l’Impero dell’Arbeit.
Ma chi è l’Arbeiter?
Il suo carattere è marziale. Tra tutte le svolte prese dal mondo del lavoro, dice Jünger (Il lavoratore), quella che mira all’armamento è la più importante. Nel campo di lavoro non c’è alcun mezzo che non sia nello stesso tempo un mezzo di potere. La guerra tende a impadronirsi di tutti i campi di attività, anche di quelli in apparenza più estranei a essa, e diventa guerra totale. La differenza tra campagna e città tende a sfumare. La differenza tra fronte di combattimento e territorio della patria, fra forze armate e popolazione, tra industria in generale e industria degli armamenti, è cancellata. Le flotte aeree che trasportano turisti sulle rotte mondiali, non hanno bisogno di essere convertite in squadriglie militari. Lo strumento tecnico, l’aereo, non è neutrale. È impiantato in una struttura che lo rende pronto ad essere micidiale.
L’aereo parte da un aeroporto civile, interno, e si scaglia contro le Twin Towers. Il nemico proviene dall’interno, dalle retrovie. Un volo civile parte da una città turistica e diffonde un virus in una città industriale, mettendola in ginocchio. Una centrale nucleare civile esplode a Černobyl. A Fukushima, uno tsunami innesca e fa detonare una bomba atomica impiantata in una centrale elettrica civile. Non si tratta di armi, o di mezzi civili convertiti. Si tratta di strumenti che hanno i connotati specifici e il carattere del lavoro. Perciò, dice Jünger, sarebbe errato credere che il cosiddetto disarmo totale riesca a diminuire il pericolo di guerra. Si possono mettere al bando la guerra chimica o stabilire il contingente di gas tossici che ciascuno Stato può immagazzinare, ma non ha senso cercare un’intesa sullo sviluppo raggiunto dalla chimica, quando l’azoto va bene sia per l’agricoltura sia per la guerra, e un aereo che sparge pesticidi è effettivamente un’arma di distruzione. Si può abolire l’apparato militare, dice Jünger, ma non il fatto che la volontà di formare ordinamenti modellati militarmente investe intere popolazioni – e forse le investe con certezza tanto maggiore quanto più gravi sono le amputazioni cui è sottoposto l’armamentario bellico vero e proprio.
La Mobilitazione Totale abbraccia non soltanto l’insieme delle riserve in uomini e cose organizzate in un contesto unitario, ma si contraddistingue anche per la variabilità e la duttilità dell’impiego di uomini e mezzi. L’attacco e l’offensiva cercano di raggiungere non più i fronti di combattimento nel vecchio significato della parola, ma le zone più profonde dello spazio da conquistare con i suoi impianti e le sue popolazioni, impiegando mezzi molteplici, non soltanto specificamente bellici, e le misure di controffensiva si basano non più soltanto sulle forze armate, ma sulla pianificazione articolata dell’energia nel suo insieme.
La Mobilitazione totale è un tutto che è di più della somma delle parti. Il Totalitarismo borghese non ha rapporti con la totalità, vede le parti solo come astrazioni, come pezzi fungibili, e non come membra di un organismo. Due mani e due piedi e una testa attaccati ad un tronco non fanno un essere vivente. La vita dell’organismo è più della somma delle parti che compongono il corpo. Ciò che permette alla mano di afferrare, non sta né nella mano, né nel braccio, né nella testa, né in queste membra considerate nel loro insieme, ma sta nella totalità vivente, la quale non è un’entità trascendente che dà un senso (vita) alle parti del corpo. La vita è immanete al corpo, anche se, guardando con il microscopio, essa non si trova in nessuno dei suoi elementi. La vita – la totalità – non si trova in un osso. L’infinito – la forma, la totalità, la vita – è nel finito. Questo è il significato di ciò che Jünger chiama metafisica, e che Hegel chiama l’universale concreto, l’Assoluto stesso in quanto esiste come Universale concreto, come totalità (Hyppolite).
II
Le condizione dell’esperienza sono le condizioni stesse degli oggetti dell’esperienza. Non c’è separazione tra soggetto e oggetto. Nessun confine con la cosa in sé. Si è già presso le cose. E le cose sono conosciute nel loro utilizzo, nel loro essere sotto mano, nel loro essere utensili. Niente intelletto contrapposto ad un oggetto della conoscenza teorica.
Tutto ciò non rimanda solo al tema dell’esperienza in Hegel (Introduzione alla Fenomenologia – anche Heidegger Il concetto hegeliano di esperienza), rimanda anche all’intenzionalità della fenomenologia e alla zuhandenheit di Essere e tempo.
Ma che cos’è l’esperienza?
L’esperienza, dice Hegel, è il sapere immediato, la percezione, in cui la percezione sono io stesso.
È assurdo credere in una percezione che non sia esperienza di colui che percepisce. Dunque, ciò che percepisco e sento, ciò che argomento e dico, è – esiste – nell’esperienza.
Secondo la tradizione illuminista, che rimanda all’empirismo inglese, l’esperienza (Locke) è quell’atteggiamento passivo, mediante il quale l’intelletto, tramite la sensazione, riceve l’impressione delle cose quali esistono, e forma le idee semplici. A questo punto, mediante un’azione attiva, l’intelletto, attraverso comparazione, distinzione e contrapposizione, separazione o astrazione, ricava i concetti generali, quali spazio, tempo, esistenza, unità, diversità, causa ed effetto.
Nulla è più superficiale di questa idea, dice Hegel. La cosa stessa di cui si tratta – l’essenza – non viene affatto sfiorata. Ci si rivolge ad un determinato, compreso in un rapporto concreto, poi l’intelletto da una parte astrae, a dall’alta fissa. Ci si limita a porre a fondamento la traduzione del determinato nella forma dell’universalità. Ma questa essenza universale che viene posta a fondamento è proprio ciò di cui bisogna dire cosa sia. Lo stesso Locke, dice Hegel, alla fine è costretto a confessare di non sapere minimamente cosa sia lo Spazio.
Questa formulazione dell’Universale proposta da Locke, nonostante la sua patente infondatezza, è diventata famosissima – dice Hegel. Cosa c’è di più chiaro che il dire che abbiamo il concetto di tempo perché percepiamo, non propriamente vediamo, il tempo, e dello spazio perché lo vediamo?
Il fatto è, dice Hegel, che Spazio, Causa, Effetto, ecc., sono categorie. La questione è: In che modo queste categorie vengono al particolare? In che modo lo spazio universale perviene a determinarsi?
Infine, Locke distingue le essenze (universali) in essenze reali e in essenze nominali. Le prime esprimono la vera essenza delle cose, mentre le seconde esprimono un che di esistente negli oggetti, ma senza esaurirlo.
Nell’idealismo e nello scetticismo successivi, il pensare in generale viene considerato come il semplice, il generale essere identico a sé, come un movimento negativo per il quale il determinato (il particolare) viene tolto. In quanto negazione del determinato – negazione assoluta – questo idealismo diventa scetticismo. Lo scetticismo è l’autocoscienza e la certezza di sé poste come intera realtà e verità. La peggior forma di questo idealismo inglese, dice Hegel (Storia, 3,1,15), è quella secondo cui l’autocoscienza singola e formale non sa dire altro senonché tutti gli oggetti sono nostre rappresentazione [Idealismo soggettivo: Berkeley, Hume].
Locke ripone la sorgente della verità nell’esperienza, nell’essere percepito. Da ciò Berkeley conclude dicendo che l’essere di tutte le cose è il loro essere percepite. Tutto ciò che sappiamo della cosa si riduce a nostre determinazioni.
Anche Hume si propone di completare il pensiero di Locke. Richiama l’attenzione sull’esperienza come fondamento della conoscenza. La percezione contiene tutto ciò che avviene. Tuttavia, argomenta Hume (Hegel, Lezioni, 3,II,230), l’esperienza, in quanto percezione sensibile, non contiene necessità, non contiene nesso causale. La percezione immediata si riferisce a un contenuto di condizioni di fatto o di cose, che esistono l’una accanto all’altra e l’una dopo l’altra, ma non a ciò che chiamiamo causa ed effetto. Nella successione del tempo non c’è causa ed effetto, e di conseguenza neppure necessità (legge). Quando diciamo che la pressione dell’acqua è stata la causa della rovina della casa, non si tratta di un’esperienza pura. Abbiamo visto l’acqua che faceva pressione o si muoveva in un dato luogo, e che poi la casa è crollata. La necessità non è giustificata dall’esperienza, siamo noi a introdurla nell’esperienza: è escogitata da noi accidentalmente, è soltanto soggettiva. Questa specie di universalità, che noi colleghiamo con la necessità, Hume la chiama abitudine. Siccome abbiamo visto più volte le conseguenze, ci abituiamo a ritenere necessario il nesso. La necessità, per Hume, è un’associazione di idee del tutto accidentale. Nulla assicura che l’evento successivo si verifichi secondo l’evidenza dei precedenti.
Quel che percepiamo sono singoli fenomeni, sensazioni, in cui vediamo che una cosa ora è così e poi è altrimenti. Può darsi che questa medesima determinazione la si percepisca più volte e in varie occasioni. Ma tutto ciò è ancora molto lontano dall’universalità, la quale è una determinazione che non ci è data dall’esperienza.
La conoscenza del nesso causale, o dell’universalità, del genere, non nasce da concetti apriori, ma dalla pura e semplice esperienza. Dall’attendersi da cause simili effetti simili. Non c’è conoscenza fuori dall’esperienza, non c’è metafisica. Ciò che si conosce è solo il finito, ma siccome il finito si estende indefinitamente, ciò che conosciamo sono solo illazioni, abitudini di pensiero, opinioni, consuetudini, le quali non sono più vere delle chiacchiere, in quanto non hanno, come le chiacchiere, alcun punto assoluto di ancoraggio.
La necessità e l’universalità non sono giustificate dall’esperienza – dice Hume. Siamo noi ad introdurle nell’esperienza. Sono escogitate da noi accidentalmente, e sono soltanto soggettive. Necessità e universalità sono associazioni di idee del tutto accidentali. Il soggetto è tutto, l’oggetto è niente. Si potrebbe dire con Nietzsche, tagliando un po’ corto, che non ci sono fatti, ma solo interpretazione, che la verità è presa di posizione.
III
Hegel mette al lavoro lo scettico. Questa è la sua astuzia. Non lo rigetta. Non lo confuta. D’altronde, per un hegeliano, confutare sarebbe ridicolo, tanto quanto chi cerchi di confutare la notte con il giorno. In Hegel la logica non è formale, è metafisica. Lo scetticismo è un momento dell’autocoscienza.
L’esserci immediato (Hyppolite), il sensibile trovato, è negato, e questa prima negazione consente all’immaginazione di disporre del dato in sua assenza, di evocarlo come assenza. Non è più la cosa stessa a essere presente, dice Hegel, ma io che mi ricordo della cosa e la interiorizzo. Io non vedo più, non sento più la cosa, ma l’ho vista, l’ho sentita.
L’Io, negando il sensibile, ancora lo conserva come un’eco, come un rimando. Ci si riferisce a ciò che non è presente in ciò che è presente ([Hegel, PhG I, 84). Senza questo gioco delle forze, senza questo differimento, senza l’uscita fuori, senza il differenziarsi, non si dà pensiero.
L’esperienza non è dunque un rapportarsi al mondo. Prima dell’esperienza non si dà alcun mondo. L’esperienza non è azione o attivismo che si imbatte in qualcosa che sta davanti, immobile, dato. Il dato può saltare fuori da un’esperienza possibile, mai essere la sua condizione. Il lavoro non si applica ad una materia prima disponibile. Non c’è alcuna materia prima. La materia del materialismo è un’astrazione – ovvero, è già una lavorazione. La materia prima è sempre già un semilavorato. L’attività lavorativa è direttamente azione. Il lavoratore non ha bisogno di passare all’azione, il lavoro è immediatamente azione. Lo stesso dicasi per la scienza. La scienza è immediatamente immischiata nelle cose del mondo. Non esiste lavoro neutro, come non esiste scienza neutrale.
Il lavoro è innestato in una struttura di rimandi. Non si introduce nel mondo, perché non c’è alcun mondo fuori dal lavoro. In questo senso è da intendersi il rimando di Jünger alla metafisica.
La Fenomenologia (il libro) non è un manuale d’uso per l’esperienza, un metodo per fare esperienze vere o autentiche. Non è nemmeno il racconto di un’esperienza. È un’esperienza. E siccome è un’esperienza, una lettura che voglia essere fedele alla sua lettera deve, essa stessa, essere un’esperienza. Anzi, non può che essere un’esperienza.
Sembra che così, dice Heidegger, Hegel abbandoni tutte le conquiste della filosofia moderna.
È opinione corrente, dice Heidegger, che la conoscenza sia intesa come un mezzo del cui impiego corretto bisogna preoccuparsi.
Per Hegel, l’esperienza (Heidegger, Hegel) è un viaggiare (pervagari) che intraprende un cammino. Ma il cammino non esiste per viaggiare, non è un andare incontro all’antagonista, la sua accettazione.
Ciò a cui si va incontro non è lì già apparso, ma appare insieme all’esperienza. L’esperienza è il viaggiare, ma è un viaggiare che si costruisce costruendo il suo cammino.
Al di fuori dell’esperienza non si dà alcuna natura, alcuna struttura rispetto alla quale la scienza si presenterebbe come una sorta di sovrastruttura, una sovrastruttura che è pur sempre un qualcosa, ma un qualcosa che, rispetto alla struttura che non erra, può anche errare ed essere contraddetta – smentita – dalla struttura, può, rispetto a questa, smarrirsi, perdersi, confondersi, sbagliare, e, per via di questo smarrirsi, anche perire, dissolversi, sparire. Oppure può correggere il tiro, rimettersi in carreggiata, eccetera. Per Hegel non vi è alcuna struttura, alcuna natura, alcun oggetto fuori dall’esperienza. L’oggetto e il soggetto, la natura e la cultura, eccetera, sono momenti dell’esperienza. Perdersi non è un errore. Perdersi non è nemmeno un segno che la struttura è cambiata, che c’è del nuovo, e che tutto quello che sapevamo non funziona più nel nuovo contesto. Perdersi è l’unico modo affinché il nuovo si affacci. Perdendosi, la storia comincia, e cominciando, l’assoluto si lacera, e lacerandosi si sdoppia, e sdoppiandosi si rispecchia, e rispecchiandosi si riconosce, e riconoscendosi si ricompone.
Oggi si dice fare esperienza di una cosa. Viaggiare, andare all’estero per fare esperienza della vita. Lo si dice proprio a partire dal concetto hegeliano di esperienza. Un concetto in cui non c’è separazione tra la conoscenza e la vita vissuta. La conoscenza non è una guida turistica. Da qui l’idea dell’industria del turismo secondo cui il viaggio autentico è prima di tutto un perdersi, un viaggiare senza guida, senza meta, senza metodo. Un viaggiare che inizia con un perdersi, e finisce con un ritrovarsi. Perdersi per ritrovarsi.
L’andare incontro a ciò che non è ancora apparso è l’andare a zonzo, è l’esperienza stessa, l’andare senza che la meta appaia esterna al viaggio, senza che il senso o il percorso siano esterni al viaggio, dove l’andare è la meta stessa.
L’andare è un mettersi alla prova, è un perdersi per poi ritrovarsi. Viaggiare è un provare e un rimettersi alla prova. È un esame.
L’esame non è un commisurare la tesi alla realtà effettiva – un esperimento. L’esperienza del viaggio non è un commisurare il cammino percorso rispetto alla guida turistica o alla prenotazione. L’esperienza deve far avverare un nuovo oggetto. Se l’esperienza non si concretizza in questo avveramento non può ritenersi vissuta, cioè vera. Siamo in un ordine diverso di verità, rispetto a quello che prospetta l’illuminismo.
Non si viaggia per conoscere, per assaggiare, per visitare. Quand’anche il viaggiare fosse un conoscere e un degustare o un visitare, l’esperienza non riguarderebbe l’ente. Non si tratta del gran tour storico, compiuto appunto per recarsi e risiedere nei luoghi dove gli oggetti della conoscenza – libri, dipinti, monumenti, musica, eccetera – sono disponibili. Si tratta dell’on the road di Kerouac, si tratta di un’andata che è un perdersi per ritrovarsi. Non si tratta delle ferie operaie.
È il viaggio spacciato come esperienza dal tour operator, è l’avventura, la sorpresa, o, al limite, il non ritorno, come possibilità estrema del ritorno o del ritrovarsi.
L’esperienza è dunque un perdersi, smarrirsi, alienarsi. La nuova esperienza compiuta, presuppone un perdersi e soffrire, lacerarsi e alienarsi.
L’esperienza, dice Hegel, è un potere – sopportare, soffrire.
La coscienza, per elevarsi, deve smarrirsi. L’elevazione implica un primo movimento, l’uscire fuori. Questa uscita fuori nell’erezione, è pungente, come pungente è ogni esporsi al fuori - anche se qui parlare di fuori non è del tutto esatto.
La coscienza eretta ed esposta all’esame, sale sul ring, incontra l’antagonista – momento della negazione determinata, del limite. Esperienza del limite, che è anche uno spingere per aprirsi un varco, una penetrazione della cosa, tra le cose – momento masochista. Il dolore come momento costitutivo della posizione tetica.
Eccomi (da-sein): l’erezione!
Il percorso dell’esperienza, dice Hegel, è un cammino della disperazione, e, di conseguenza, l’esperienza è essenzialmente dolorosa.
Hegel, infatti, pensa sempre il dolore metafisicamente, vale a dire come una sorta di coscienza, la coscienza di essere-altro, della lacerazione, della negatività.
Lacerazione del sé, che erigendosi esce fuori di sé, e si oppone al sé come un suo doppio – alienazione – il sé non si riconosce come proprio sé alienato.
L’esperienza della coscienza, dice Heidegger, in quanto esperienza trascendentale-dialettica, è la «cattiva esperienza».
L’esperienza è «cattiva esperienza», nella quale ciò che è saputo si mostra sempre altro da come appare inizialmente. L’esperienza è il dolore trascendentale della coscienza.
La coscienza esce fuori, si rizza. Elevarsi è fare esperienza dell’essere fuori, ritta, nell’atto di penetrare la cosa. Cosa tra le cose, si scopre diversa da come credeva di essere. Tra gli altri, esiste, si ritrae, toccata e rintuzzata, si ritira. Dolore nell’erezione – toccata dall’altro.
L’esperienza, dice Heidegger, è il lavoro del concetto.
Il concetto non è idea dell’oggetto – mera opposizione cartesiana – il concetto è questo viaggio. Uscire fuori di sé. Penetrare la cosa, tornare in sé.
L’esperienza della coscienza, dice Heidegger, in quanto percorso, in quanto esame, in quanto patire (sopportazione e compimento), in quanto dolore, in quanto lavoro, è dovunque e sempre anche acquisizione di conoscenza di nozioni.
Ma questo acquisire nozioni non è mai una mera percezione, bensì il lasciar-apparire che, in quanto percorso e viaggio, esperisce e quindi consegue sempre una figura essenziale della coscienza.
Heidegger ribadisce che l’esperienza dell’elevazione non può essere una mera conoscenza, per così dire, intellettuale. L’elevazione-erezione ha bisogno di passare all’azione, deve uscire fuori e penetrare la cosa.
Che l’esperienza non sia mera conoscenza, non vuol dire che non produca un sapere, una conoscenza e delle nozioni. Conoscenza e nozioni non sono, rispetto all’esperienza, per così dire, una sovra-struttura, sono l’esperienza stessa. Il concetto non è il manuale di istruzioni dell’esperienza, il film pornografico rispetto alla copula effettiva, la guida turistica rispetto al viaggio, la copula a pagamento rispetto all’avventura, l’agenzia di viaggio rispetto allo sci fuori pista, il senso d’orientamento rispetto google maps.
E tuttavia l’esperienza produce conoscenze, savoir-faire, Know-how. Non si può fare esperienza per procura, imparare dall’esperienza di un altro. O meglio, imparare è sempre possibile, imparare da un altro è possibile, imparare da un un altro è ancora un’esperienza, è un’esperienza esperita in prima persona, ma non si tratta dell’esperienza di cui l’altro ci insegna, ma è l’esperienza dell’imparare. Imparare a contare i soldi non è uguale a contare i soldi incassati – sono esperienze diverse, incommensurabili. Guardare la partita dagli spalti, non è uguale a giocare. Tuttavia è pur sempre qualcosa. È l’esperienza del tifoso. Perciò, dice Heidegger, l’esperienza della coscienza non è soltanto e primariamente una sorta di conoscenza, bensì è un essere, e precisamente l’essere dell’assoluto apparente, la cui essenza stessa riposa nell’auto-manifestarsi incondizionato.
L’esperienza è l’assoluto che diventa fenomeno, e in quanto fenomeno, si manifesta alla coscienza.
IV
Le cose in mezzo alle quali il Dasein esiste sono oggetti di cura e di preoccupazione (das Besorgte). Sono cose che si offrono alla mano, invitano alla manipolazione. Servono a qualcosa: le asce per tagliare il legno, i martelli per martellare il ferro, le maniglie per aprire le porte, le case per abitarci, ecc. sono, nel senso proprio del termine, dei mezzi (Zeuge).
Qual è il loro modo d’essere? Chiede Lévinas (Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger).
L’essere del mezzo, dice Lévinas, non si identifica con quello di un semplice oggetto materiale che si rivela alla percezione o alla scienza. La contemplazione non è in grado di cogliere l’ente in quanto tale. È attraverso l’uso, la manipolazione, che abbiamo accesso ad esso in modo adeguato e del tutto originale. La manipolazione non incontra gli oggetti solo in modo originale, ma anche in modo originario: non è successiva ad una rappresentazione. È per questo che Heidegger si oppone all’opinione corrente secondo cui prima di manipolare qualcosa è necessario rappresentarselo.
I mezzi (tecnici) sono gli oggetti che il Dasein scopre in un modo determinato della sua esistenza: la manipolazione. Non sono delle semplici cose. La manipolazione è, in un centro senso, l’effettuazione del loro essere. Essa non determina ciò che essi sono, ma il modo in cui incontrano il Dasein. L’essere dei mezzi è l’utilizzabilità (Zuhandenheit). Ed è proprio perché la manipolazione non è successiva a una rappresentazione, che l’utilizzabilità non è una semplice presenza (Vorhendenheit) sulla quale verrebbe a innestarsi una nuova proprietà. L’utilizzabilità è assolutamente irriducibile e originaria.
Qual è la struttura dell’Utilizzabilità? chiede ancora Lévinas.
Essa è essenzialmente costituita dal Rimando (Verweisung). Il mezzo, dice, è «in vista di» qualcosa. Per questo non è un essere separato, ma è sempre in connessione con altri mezzi. Appartiene anzi al suo modo di essere il fatto di far posto alla totalità dell’opera in rapporto alla quale è. Il mezzo è nel suo ruolo adeguato – e l’utilizzabilità caratterizza il suo essere in sé – solo quando tale utilizzabilità non è esplicita, ma si ritira sullo sfondo e il mezzo è compreso a partire dall’opera. Anche quest’opera è, a sua volta, un mezzo: la scarpa esiste per essere portata, l’orologio, per indicare l’ora. Ma, dice, d’altra parte, la costituzione dell’opera è l’utilizzazione di qualcosa in vista di qualcosa. Il mezzo rinvia dunque ai materiali. È così che, a partire dal mezzo, scopriamo la natura, le foreste, le acque, le montagne, i metalli, il vento, ecc. La Natura scoperta in tal modo, dice, è del tutto relativa alla manipolazione. Non ci sono le foreste, ma il legno, le acque sono carbone bianco o mezzi di trasporto, la montagna è la cava, il vento è vento in poppa. Infine, dice, l’opera non è fatta soltanto in vista di qualcosa, ma anche di qualcuno. La costruzione si orienta sul consumatore; gli uomini in quanto consumatori si rivelano con il mezzo, e con essi si rivela la vita pubblica e tutto l’insieme delle istituzioni, tutto l’apparato della vita pubblica. L’insieme dei rimandi che costituiscono l’essere del mezzo ci conduce ben aldilà della ristretta sfera degli oggetti usuali che ci circondano. Attraverso la manipolazione noi siamo così presenti nel mondo, nel «mondo» nel senso corrente del termine, compreso l’insieme delle cose. Ma rispetto a tale insieme, noi non siamo solamente spettatori, né siamo un contenitore di esso. La manipolazione descrive la nostra inerenza al mondo come originale e originaria e come condizione del rivelasi stesso del mondo a noi.
Quando il mezzo è guasto, esso spezza il sistema (di rimandi) rispetto a cui è, e perde, per così dire, il suo carattere di mezzo, per diventare, in una certa misura, una semplice presenza. In questa perdita momentanea dell’Utilizzabilità il «rimando a ciò in vista di cui il mezzo è» si risveglia, emerge, si mette in luce. Ci troviamo così rivolti verso la totalità del sistema dei rimandi, la quale, implicitamente, è sempre compresa, ma che sino a questo momento non era stata esplicitata. Si tratta di una serie di rimandi che può attuarsi solo in un «ciò in vista di cui» che non è più in vista d’altro, ma in vista di se stesso. In tale struttura, dice Lévinas, riconosciamo il Dasein stesso. La comprensione del mezzo, in altri termini, si compie unicamente in rapporto a una comprensione iniziale della struttura del Dasein che, grazie al «rimando a se stesso» che gli è proprio, permette di comprendere nei mezzi stessi la loro utilizzabilità, il loro uso possibile, il loro «in vista di». In tal modo si annuncia il mondo. Il quale non è costituito dalla somma dei mezzi, poiché proprio la totalità dei rimandi rende possibili i mezzi solo a condizione di rimanere sullo sfondo. Ma essa ne è la condizione ontologica. Ne è la condizione, poiché, per comprendere «l’in vista di» costitutivo del mezzo, è necessario comprende «ciò in vista di cui esso è» che, a sua volta, rinvia a qualcos’altro e che si compie nel Dasein.
Questa totalità è una condizione ontologica. E questo perché l’utilizzabilità non è una proprietà, ma un modo d’essere del mezzo.
Il tema della Totalità organica e dello Zuhandenheit è vicino anche al tema di Marx della prassi.
I πράγματα (prágmata) non vanno intesi come il corrispettivo di una conoscenza, perché in questo caso si assume in anticipo una implicita caratterizzazione ontologica (reificazione). I πράγματα (prágmata), dice Heidegger (Essere e tempo), vanno intesi come Zeug (uso-per). Nella pratica, dice, non sono reperibili meri oggetti (o materie prime), ma sono reperibili enti che si usano-per-scrivere (Schreibzeug), -per-cucire (Nähzeug), -per-operare, -per-viaggiare, -per-misurare. E lo stesso oggetto – una penna – può essere usato per scrivere, può essere usato come segnalibro, può essere usato per grattarsi la schiena. Dunque, dice Heidegger, una Zeug, a rigore, non «è» mai. Non è una mera cosa, non è un sostrato, non è una materia prima. Se essa è, lo è sempre in vista della sua utilizzabilità. All’essere di ciò che si usa-per (Zeug) appartiene via via sempre una totalità di usi-per, nella quale questo uso-per può essere quello che è. In quanto usato per questo o per quello, dunque nella utilizzabilità, è sempre compreso un rimando di qualcosa a qualcosa, in un insieme di rimandi. L’uso per, dice Heidegger, data la sua natura di uso-per, è sempre a partire dall’appartenenza a qualcos’altro che si usa-per: penna usata-per scrivere, inchiostro, foglio, cartelletta, tavolo, lampada, mobili, finestre, porte, camera. Queste «cose», dice, non si mostrano in prima istanza ognuna per sé, per poi, in quanto somma di reali, riempire una stanza. Quella che si incontra per prima, benché non venga colta tematicamente, è la camera, e questa, di nuovo, non come ciò che «sta tra le quattro pareti» in senso geometrico-spaziale, ma come ciò che si usa-per abitazione. A partire da questa si mostra la «sistemazione dell’arredamento» e, al suo interno, quello che via via è il «singolo» uso-per. Prima di quest’ultimo è via via già svelata una totalità dell’uso-per.
Il martellare, dice Heidegger, non possiede un mero sapere circa il carattere d’uso-per del martello, ma si è appropriato di questo uso-per martellando. Non c’è da una parte una teoria che, applicata alla mera cosa martello, produce il martellare come pratica. È il martellare stesso a svelare la specifica «maneggiabilità» del martello. Il modo d’essere usato-per, nel quale esso si palesa da se stesso, Heidegger lo chiama essere-allamano (Zuhandenheit). Allo sguardo che guarda solo «teoreticamente» alle cose fa difetto la comprensione dell’essere-allamano (Zuhandenheit). La pratica – la prassi – non è cieca. Il contegno «pratico», dice, non è «ateoretico», non gli manca una visione, e la sua differenza rispetto al contegno teorico non sta soltanto nel fatto che qui si osserva e là si agisce e che l’agire, per non restare cieco, impiega un conoscere teoretico, ma piuttosto come l’osservazione è originariamente un curarsi di…, così l’agire ha la sua visone.
Non ci sono, da una parte, la teoria, e, dall’altra, la prassi. Non si passa dall’una all’altra. Anche la teoria, intesa come mero guardare, si dà nella pratica teorica. Il conoscere risulta dall’avere a che fare pratico con il mondo.
Ciò presso cui la pratica quotidiana si intrattiene, dice Heidegger, non sono neppure gli utensili adoperati in quanto tali, ma è l’opera, ciò che via via deve essere prodotto. È essa ciò di cui primariamente ci si preoccupa, e ciò che è quindi primariamente allamano (Zuhandene). L’opera, dice, è portatrice della totalità di rimandi all’interno della quale è incentrato ciò che si usa-per.
L’opera da produrre, dice Heidegger, in quanto inquadrata in una struttura di rimandi, in quanto è l’a-che (Wozu) di martello, pialla e ago ha, da parte sua, il modo d’essere dell’uso-per. La scarpa, dice, va prodotta per essere calzata (il suo è un uso-per calzatura - Schuhzeug), l’orologio è posto in uso-per leggervi l’ora. L’opera in lavorazione ci fa sempre anche incontrare l’a-che (Wozu) della sua impiegabilità. L’opera su ordinazione è eseguita solo sulla base del suo utilizzo e sulla base della connessione di rimandi tra gli enti in esso svelati.
Come si vede immediatamente, queste considerazione di Heidegger sulla produzione e sul prodotto, sulla materia prima e sulla manodopera, sono vicine a quelle dell’Introduzione del 57 di Marx.
Il materialismo di Marx non è il corrispettivo dell’idealismo, non è un’inversione dell’idealismo. L’essenza del suo materialismo non sta nell’affermazione che tutto è materia, ma piuttosto in una determinazione fondamentale per la quale tutto l’ente appare come materiale da lavoro. È errato pensare il marxismo e il materialismo dialettico come la semplice affermazione della materia o di un fondamento in ultima istanza materiale. Bisogna, invece, pensarlo a partire dall’essenza del lavoro, dalla trasformazione, dal lavoro di trasformazione.
Nelle sue Lezioni sulla storia della filosofia, a proposito della filosofia francese, cioè dell’illuminismo, Hegel dice quanto segue. Essa si rivolta contro l’intero mondo, distrugge tutto ciò che è fisso, e si dà la coscienza della propria libertà. Non resta in piedi alcuna distinzione, alcun contenuto. Nella sua furia negativa ogni singolarità effettiva viene abbattuta, ogni testa cade, senza distinzione. Il terrore è la sua logica conclusione. Ciò che rimane, dice Hegel, è una vuota essenza, il puro pensare, che i francesi chiamano Être suprême, di fronte al quale ogni contenuto effettivo, ogni particolarità e differenza, si trasformano in numero. Enumerate sono le teste, in serie o in filari, ammassate le une accanto alle altre, in insiemi di individui sconnessi, astratti, tratti appunto fuori dai loro contesti, dalle situazioni in cui sono gettate, fuori dalla struttura di rimandi, de-vitalizzate. Contrapposte alla scienza o all’intelletto queste serie enumerabili sono la materia – la materia del materialismo.
L’Être suprême, dice Hegel, è la materia, l’oggettività vuota. Oggettività che viene ottenuta ad opera del concetto, che distrugge ogni contenuto e determinazione, ed ha per suo oggetto soltanto l’universale astratto.
All’illuminismo non resta (Hegel, Fenomenologia dello Spirito, il Terrore), non resta che l’operare negativo, la furia del dileguare. L’unica sua opera può essere l’annientamento continuo dell’ente determinato che emerge sempre di nuovo. Se il governo è sempre colpevole in quanto agisce effettivamente, viceversa, per tale governo, la massa è sempre sospetta. L’unica cosa in cui l’illuminismo può riconoscersi senza intoppi è l’uniformità dei cittadini davanti alla legge; l’unica azione che il governo può rivendicare senza piombare a terra nei sondaggi è il Reddito universale di cittadinanza. L’unico motto in cui può riconoscersi, oltre al sibilo della ghigliottina, è: «Io sono tutto, voi non siete un cazzo!», parafrasi felice del motto del Terzo Stato – inventato da Sieyés. Di fronte all’intelletto può dispiegarsi solo la materia del materialismo. Il concetto si comporta da distruttore, presentandosi come pensiero puro o pura sostanzialità. Da qui, dice Hegel (Lezioni), si vede sorgere il cosiddetto materialismo e ateismo, e perdersi tutto ciò che è tradizione, costume, storia. L’illuminismo appare qui come il risultato dell’astrazione intellettualistica che parte dall’empirismo. Appare il fanatismo del pensiero astratto.
Bisogna ricordare che qui «astratto» non si riferisce a qualcosa di inconsistente, di meramente pensato. Bisogna pensare l’astrazione come un modo di essere, come una forza, come un agire. Allora l’astrazione diventa il modo di essere dell’illuminismo – diventa terrore, ghigliottina e teste che cadono nel paniere. Oppure diventa ascesi, ritiro dal mondo, diventa «anima bella», chiusura nel silenzio interiore, tale da non infrangere la propria purezza. Tentativo di trovare in fondo all’anima e dunque in se stessi l’assoluto divino, ovvero la libertà, nella sua immediatezza, ovvero nella sua sovranità e semplicità. Tentativo, tuttavia, che può dissolversi solo nel nulla. Questa pura vita interiore è illusione (Hyppolite, Genesi e struttura). La coscienza non può rinunciare all’universalità né rifiutare la determinazione che, essa sola, le conferisce l’esserci. Un simile rifiuto la condurrebbe solo a quella dissoluzione che abbiamo visto sempre minacciare la singolarità astratta, astratta appunto in virtù del rifiuto delle determinazioni, e dunque identica all’astratta universalità. L’anima bella compie in sé, ma senza quella ingenuità, lo stesso movimento compiuto dalla coscienza immediata, che si credeva unica e posta al di qua del discorso. L’anima bella finisce per smembrarsi fino alla follia e sprofondarsi nell’immediatezza dell’essere puro o del nulla. La sola possibilità di risolvere la determinazione opaca nella trasparenza dell’universale, di sciogliere il nodo, è quella di comunicare attraverso il linguaggio, di accettare il dialogo.
Accanto all’universale astratto, e come suo corrispettivo, emerge il singolare astratto. Si scappa dalle cose o si scappa nelle cose. L’asceta e il romantico. Ci si libera in quanto sovrani o in quanto martiri. Nel caso del romantico si tratta di un ritorno all’indietro. Liberarsi del fardello dell’intelletto, perdendosi nelle cose, nel godimento immediato. Non accettare alcuna mediazione, rimanere puri. Sciogliersi di piacere, sciogliersi nelle mondo, dileguare, immolarsi, lanciarsi come un kamikaze, balbettare, sparare sentenze a peto di ciuccio. Il romantico sa che «grigia è ogni teoria e verde l’albero d’oro della vita», disprezza l’intelletto e la scienza, i doni supremi dell’uomo, ma si consegna allora al diavolo e deve far ritorno al fondamento. Aspirando all’immediato, come Faust, la coscienza aspira, senza neanche saperlo, a dileguare. Come coscienza singola che vuole vivere l’ineffabile e rinuncia al pensiero, desidera prendere la vita come si coglie un frutto maturo che si fa incontro alla mano che lo afferra, ma, anziché lanciarsi dalla morta teoria alla vita stessa, si precipita piuttosto nella morte, nella dissoluzione della propria singolarità. Questo dissolversi non può venire compreso dalla coscienza, perché essa ha preteso di risalire al di sotto della mediazione che, essa sola, costituisce una autocoscienza come tale. Volendo andare a fondo di questa singolarità pura, ne trova il fondo: la dissoluzione – dacché il sentimento non serba in se stesso il senso esplicito dell’accadere. Il suicidio di tanti poeti romantici – russi, in particolare (Jakbsonb, Una generazione che ha dissipato i suoi poeti) – è il regolare happy end.
Adesso abbiamo tutti gli elementi per leggere Jünger. Abbiamo l’odio verso l’illuminismo, il razionalismo, la scienza. Odio che Jünger eredita dal romanticismo. Abbiamo l’elogio della tecnica che eredita dal tema dell’esperienza di Hegel, e che oppone al romanticismo, come già aveva fatto Hegel. Abbiamo un odio viscerale per il capitalismo e il liberalismo, che aveva già espresso anche Hegel, e un recupero (Aufhebung) del capitalismo e dell’illuminismo, che aveva già espresso Hegel. Insomma, abbiamo quasi tutto Hegel, romanzato per benino, buono per ogni palato.
Poiché ho commentato solo le ultime tre pagine di Der Arbaiter, a questo punto bisogna riprenderlo in mano dalla prima pagina, e seguire tutti i passaggi, cosa che non farò, se non per sommi capi, e solo perché il testo è bello. Facendo attenzione a non farmi ingannare della singole prese di posizione, tenendo presente il quadro generale, l’hegelismo di fondo.
V
Il Momento Illuminista (tesi); Il momento Romanticismo (antitesi)
In Germania (§1), il dominio del terzo stato, il dominio della borghesia e dell’illuminismo, non è mai riuscito a intaccare il nucleo intimo che dà senso alla potenza e alla ricchezza e alla pienezza di vivere. Guardando il secolo di storia tedesca alle nostre spalle, dice Jünger, possiamo dichiarare con orgoglio di essere stati cattivi borghesi. Non siamo stati estirpati dal nostro suolo, le nostre radici affondano ancora giù nel terreno arido, fino a raggiungere la sorgente in cui riposa la magica unità di sangue e spirito che fa irresistibile la parola. L’illuminismo non ha trasformato i tedeschi in cittadini, individui-massa. Non li ha tratti fuori dal proprio contesto, facendoli valere come unità fungibili. La parola tedesca simboleggia ancora l’unità romantica, atavica, di sensibile e intelligibile. Il tedesco non ha mangiato il frutto della conoscenza che ha avvelenato i francesi. Il tedesco, dice Jünger, non seppe mai fare uso di quella libertà che prese corpo nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. In Germania non c’è nessun uomo in generale, c’è solo questa persona qui, rinviata al suo contesto di origine. La libertà francese, dice, fu per lui uno strumento privo di qualsiasi rapporto con le zone più interne del suo organismo.
Quando l’Arbeiter sente di appartenere a un Quarto stato (§3), o crede di sentire il richiamo di una classe, è la borghesia che lo sta inquadrando. Al fondo di questa manovra c’è un’inconsapevole astuzia che cerca di imprigionare le nuove esigenze in una vecchia cornice.
Invece, bisogna sapere e considerare che l’Arbaiter è in rapporto con forze elementari di cui il borghese non ha mai avuto neppure il presentimento. L’Arbeiter ha nelle sue radici profonde la vocazione a una libertà totalmente diversa dalla libertà borghese. Il borghese libera l’Arbaiter asservendolo alla legge, lo libera recidendo le sue radici, trasformandolo in un individuo sans prhase, in un uomo senza volto e senza storia, senza personalità. Il borghese vuole incarcerare le passioni e metterle al lavoro. Respinge nell’uomo tutto ciò che vi è di aggressivo, dunque respinge la guerra, perché sente nell’intimo che l’istinto aggressivo e la malvagità non sono tagliati a sua misura. Ma qua si sperimenta anche tutta la sua ipocrisia. Non potendo emendare la violenza costitutiva, deve mascherarla o adulterarla. Così, dice Jünger, nella conquista di una colonia, il borghese sa riconoscere un fenomeno di pacifica penetrazione; nel portar via una provincia a uno Stato, vede l’autodeterminazione di un popolo; il saccheggio sulla pelle dei vinti è per lui una riparazione.
Non bisogna nemmeno cadere nell’inganno di considerare l’Arbaiter a partire dall’economia. In tutto ciò che si è detto in merito a questa connessione si è prodotto il tentativo tipicamente aritmetico (§5) di tramutare il destino in una grandezza definibile con strumenti di calcolo.
Perché la matematica costituisce un inganno?
Perché la matematica, sommando le teste, fa sembrare, o, peggio, spinge per far diventare identico ciò che identico non è. La matematica annichilisce le differenze.
Bisogna anche evitare di considerare l’Arbaiter come attore del progresso – economico o sociale. Il progresso è il trasferimento della matematica alla storia. È la dittatura del pensiero econometrico, che vuol trasformare la storia in una linea retta che avanza digitalmente senza intoppi, senza perdite, senza spargimento di sangue, in una progressione che restituisce un cattivo infinito, un surrogato di di libertà. Dichiarare l’autonomia dell’Arbaiter, l’autonomia operaia dall’economia, significa riconquistare la propria posizione nel campo di battaglia, abbandonando la posizione borghese. La lotta economia, o l’economico in ultima istanza, è una prerogativa della borghesia, e non dell’Arbaiter.
L’Arbaiter si muove sul terreno dell’autonomia operaia. Ciò, dice Jünger, non significa rinuncia a quel mondo, bensì volontà di subordinarlo a una rivendicazione di potere più vasta e di più ampio respiro. Non sono né la libertà economica, né la potenza economica, il perno della rivolta, ma è la forza pura e semplice, assoluta. Il pane senza libertà, non vale niente.
Perché l’economia non può essere un punto di partenza?
Perché l’economia borghese è l’apoteosi della fungibilità, della sostituibilità. La produzione in serie, l’operaio massa, è lo sradicamento totale. La negazione delle competenze artigiane, che erano ancora delle competenze pratiche, legate alla mano dell’artista, alla sua storia, alla sua vita, al contesto in cui era inserito, e che ancora venivano gelosamente protette dalle corporazioni, nel mondo borghese vengono incorporate nelle macchine. L’operaio diventa una appendice della macchina, un semplice manovratore, un manovale senza arte, senza sapere, senza conoscenza di quello che fa. L’operaio è ridotto a mera forza motrice, ad elemento sostituibile e rimpiazzabile, eccetera. La conoscenza si separa dalla mano. La borghesia realizza la separazione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, ponendoli l’uno di fronte all’altro, in antagonismo. La forte avversione romantica per il lavoro, direi proprio l’odio per il lavoro manuale, il vilipendio dell’attività umile e dell’operaio di fabbrica, deriva proprio dall’idea che diventare operaio significa abdicare all’assoluto, rinunciare alla libertà, rinunciare all’autonomia della politica. L’operaio non può fare politica, se la fa, la fa in nome e per conto della borghesia, che spaccia falsi miti di progresso (Battiato).
Tutti i grandi momenti della vita, gli ardenti sogni della gioventù, l’ebbrezza dell’amore, il fuoco della battaglia, la passione, il male, il lato oscuro, coincidono con una profonda unicità e con il ricordo del magico ritorno a casa che commuove il cuore e lo convince dell’immortalità di quei momenti. La parte di eredità che mai potrà essere sottratta al singolo è, dice Jünger, il suo appartenere all’eternità.
Le forze primigenie condannate dalla matematica diabolica a sfociare nel nichilismo, attendono di risorgere in un tipo nuovo di uomo. C’è un’ebrezza della conoscenza (§12), la cui origine non è soltanto logica, e c’è un orgoglio di conquiste tecniche, l’orgoglio del primo passo verso uno sconfinato dominio dello spazio, in cui si avverte un presagio di recondita volontà di potenza, ancora in germe. A questa volontà, tutte le conquiste tecniche servono da armatura per impreviste battaglie e insospettate rivolte, e proprio per questo sono tanto preziose ed esigono cure più amorevoli di quante mai un guerriero abbia dedicato alle proprie armi.
Se questo non è romanticismo!
Un romanticismo di sapore nicciano, che Heidegger, sul finire degli anni Trenta, smonterà pezzo per pezzo, indirizzando (ingiustamente) una polemica spietata contro la volontà di volontà, assimilandola, niente meno, che alla peggiore teologia, e considerando (ingiustamente) Nietzsche non come il nunzio di un nuovo tipo, ma come l’ultimo, anche se il migliore, difensore del presente.
VI
Le città (§13), già verso la fine dell’Ottocento, apparivano come le ideali roccaforti della sicurezza, come il puro e semplice trionfo del muro difensivo che da oltre un secolo si è trasformato: le antiquate cinte di fortificazioni sono diventate strutture a nido d’ape in cui pietra, asfalto e vetro rinserrano la vita. Ecco il salutato dell’illuminismo! Per esso l’energia elementare ha le sembianze dell’assurdo, e perciò il muro che segna il confine dell’ordine borghese si presenta anche come il muro confinario ella ragione.
Da cosa ci si doveva difendere?
Ci si doveva difendere dalla vita, dalla tragedia della vita, dal conflitto tragico, dall’incendio della città, in cui il guerriero può cogliere con particolare evidenza il senso della vita. Una città arsa da un incendio o devastata da un terremoto, dice Jünger, è per il criminale, cioè per il romantico, un campo di più intensa attività.
Il borghese, invece, riconosce nella sicurezza il proprio valore supremo, e la assume come punto di riferimento della sua condotta di vita. La potenza cui affida le sue speranze è la ragione. Ed essa si manifesta nel modo in cui si cerca di suddividere il rischio in parti uguali, sia nella vita privata sia nella vita pubblica, assoggettandole così alla ragione. Si vede negli sforzi con i quali si cerca di decifrare il destino mediante il calcolo delle probabilità, i sondaggi, la demoscopia, le indagini statistiche, le banche dati, gli algoritmi, i dispositivi di computo, eccetera. È visibile nei numerosi e complicati tentativi di tradurre la vita in un meccanismo di causa ed effetto, trasformando la sua natura non soggetta a calcolo in una grandezza calcolabile, e circoscrivendola nel dominio della ragione.
Eppure, dice Jünger, l’uomo vive in modo elementare, in quanto è un essere natura e, in egual misura, un essere demoniaco, e nessun ragionamento può sostituire il battito del cuore o l’attività dei reni, e non esiste alcuna grandezza, e sia pure la stessa ragione, che non si assoggetti qualche volta ai bassi o ai superbi istinti vitali. Le fonti della realtà, dice, sono nel mondo, che è sempre pericoloso, anche quando sembra calmo e benevolo, altre sono nel cuore umano, che anela all’azzardo e alle avventure, all’odio e all’amore, ai trionfi e alle cadute.
Tutto ciò, dice Jünger, può apparire ed in effetti è romantico. Ma bisogna superare il romanticismo, perché esso punta a un tempo passato che si colora del sentimento di reazione (risentimento) contro lo stato di cose che ad ogni istante si attualizza. Il romantico vuole sciogliere la ragione e le sue storture sciogliendosi nel mondo, tornando indietro, ad un periodo di indistinzione, vuole arretrare. Reagendo, la violenza della ragione si ritira, si contrae, spera di ritornare nel ventre materno: desiderio di affogare nel liquido amniotico – alla Pasolini.
Per me è importante sapere (§14), dice Jünger, che il meraviglioso, inteso come un’amorosa e quasi miracolosa evocazione di campane medievali, di contadini meridionali, di borgatari dialetto parlanti, di furfantelli o grandi criminali, veri perché genuinamente feroci e falsi dalla testa ai piedi, dunque pericoli estremi per il sistema; è importante sapere che il ritorno alla terra e alla madre, tutto ciò, insomma, dice Jünger, è uno stratagemma di chi è sconfitto dalla storia. Il romantico tenta di istituire il sistema di valori di una vita elementare, la cui validità istituisce senza però fare parte di quel sistema. Di conseguenza, inganno e delusione sono inevitabili. Il romantico riconosce l’incompiutezza del mondo borghese, al quale però egli non sa contrapporre altro mezzo se non la fuga.
A questo punto, molto ingenuamente, si potrebbe credere che Jünger, vista la squalifica del romanticismo, si butti anima e corpo dalla parte dell’illuminismo, oppure, che, in perfetta malafede, o in preda a confusione o eclettismo inconcludente, o catturato da una sorta di niccianismo della domenica, ovvero di nichilismo elementare, conservi il suo romanticismo basico, ma lo fortifichi con l’arma illuminista. Ma tutto ciò è impensabile dopo il romanticismo, e a maggior ragione dopo Hegel. Il ragionamento non è un pranzo di gala o una partita di pallone, dove cambiare sedia o colore della maglia lascerebbe tutto intatto. La verità non è più sostanza del contendere, e il ragionamento non è un rapportarsi dell’intelletto alla cosa. La verità è soggetto, la verità è storia, la verità ha una storia. Tutto diventa molto complicato, e non più semplice e più chiaro, quando si affaccia la possibilità, per il pensiero, che la ragione del più forte è sempre la migliore: se questo motto è vero è una bufala, e se è una bufala è vero.
La logica di Hegel non è una logica formale, ma è una metafisica. Per essa non ha senso dimostrare la correttezza di un ragionamento. Voler dimostrare che l’illuminismo ha ragione, sarebbe come voler mostrare che il giorno è la verità della notte. Tutto ciò non ha senso. Ad Hegel interessa rischiarare la notte, portare la luce là dove è buio, recuperare la luce alla notte, applicare la pratica teorica (la tecnica) per produrre la lampadina. La confutazione del romanticismo non la produce Hilberrt, la produce Edison. Così come la confutazione del romanticismo – ma qui parlare di confutazione è fuori luogo – la produce la borghesia, quando crea i parchi nazionali dove racchiude e porta in città l’ultimo residuo del pericoloso e dello straordinario, conservato come curiosità.
Dunque, dice Jünger, la protesta romantica, quando non è recuperata e messa al lavoro dalla borghesia, si configura come fuga. Essa è condannata al nichilismo, in quanto, ponendosi come antitesi del mondo borghese, avvertito come ostile, si vuole assolutamente indipendente da esso.
VII
Il Momento dell’Arbaiter (Sintesi).
[…]
——
Emmanuel Lévinas, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger
Jean Hyppolite, Logica ed esistenza
Jean Hyppolite, Introduzione alla filosofia della storia di Hegel
Heidegger, Hegel
Heidegger, Il concetto hegeliano di esperienza
Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia
Roman Jakobson, Una generazione che ha dissipato i suoi poeti. Il problema Majakovskij