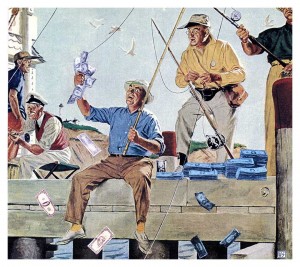Dominio e ricatto del capitalismo finanziario. Intervista ad Andrea Fumagalli
apr 4th, 2023 | Di Thomas Munzner | Categoria: Contributi
Dominio e ricatto del capitalismo finanziario.
Intervista ad Andrea Fumagalli
ANTONIO MINALDI
Dominio e sfruttamento nel capitalismo del XXI° secolo è un volume pubblicato da poco di cui consigliamo la lettura. Curato da Antonio Minaldi e Toni Casano (Ed. Multimage, 2023), il testo raccoglie i contributi di studiosi e militanti politici ad un ciclo di dibattiti su cinque grandi questioni: antropocene e capitalocene; il capitalismo della sorveglianza; il capitalismo della produzione immateriale; dominio e ricatto del capitalismo finanziario; imperi, guerra e destini del mondo. Pubblichiamo di seguito l’importante intervista sul capitalismo finanziario che Antonio Minaldi ha condotto con Andrea Fumagalli.
Abbiamo il piacere di ospitare il professor Andrea Fumagalli. Con lui parleremo di economia. Tema ostico per molti, ma di cui dobbiamo necessariamente occuparci, perché da questioni come finanza, inflazione, debito pubblico dipende in gran parte la nostra vita. Il primo punto di cui ci occuperemo è quasi obbligato, e riguarda la guerra. Chiederei al prof. Fumagalli, anzi direi al compagno Andrea, di spiegarci che cos’è che sta cambiando, e cosa cambierà nel medio lungo periodo, con la guerra in Ucraina e col passaggio da un mondo unipolare a un mondo bipolare o più probabilmente multipolare. Ricordiamo che globalizzazione, crisi dello Stato nazione e libera circolazione delle merci e dei capitali per noi sono stati, in questi anni, cose quasi scontate. Ma forse non è più così!
Iniziamo con una doverosa premessa. Il capitalismo attuale è caratterizzato dal susseguirsi di crisi sistemiche, sia che si tratti di crisi indotte dall’instabilità finanziaria oppure da tensioni geopolitiche o da eventi sindemici. La regola della crisi come fatto perenne ha innervato l’intero sistema capitalistico così come si è sviluppato dagli anni Novanta fino ad oggi. Si tratta, non a caso, del periodo in cui i mercati finanziari hanno cominciato a svolgere un ruolo centrale e dominante nei processi di accumulazione e valorizzazione capitalistica. Ciò dipende dal fatto che i mercati finanziari oggi sono il cuore pulsante del capitalismo bio-cognitivo e delle piattaforme. Essi finanziano l’attività di accumulazione: la liquidità attratta nei mercati finanziari premia la ristrutturazione della produzione finalizzata allo sfruttamento delle conoscenze, il controllo di spazi esterni al business tradizionale e la messa a valore della vita (del bios). Oltre a provvedere al finanziamento dell’attività di accumulazione, in presenza di plusvalenze, i mercati finanziari svolgono nel sistema economico una funzione redistributiva del reddito (tramite il moltiplicatore finanziario), dal momento che, soprattutto per le prestazioni di lavoro di alto livello all’interno delle imprese (dirigenti, manager e personale altamente qualificato), parte della remunerazione è costituita dalla partecipazione azionaria (stock option). Tale ruolo redistributivo è apparentemente simile a quello del moltiplicatore keynesiano del reddito nel contesto fordista (attivato dal deficit spending, ovvero dalla spesa pubblica in disavanzo). Tuttavia, a differenza del classico moltiplicatore keynesiano, il moltiplicatore finanziario porta a una redistribuzione distorta del reddito, favorendo la crescita dei redditi già più alti a scapito di quelli già più bassi. Perché tale moltiplicatore sia operativo (abbia, cioè, un valore maggiore di uno), occorre che la base finanziaria (l’estensione dei mercati finanziari) sia costantemente in aumento (con una domanda di titoli maggiore dell’offerta) e che le plusvalenze maturate siano in media superiori alla perdita del salario mediano (che negli Usa ma anche nei paesi europei ha avuto un calo di oltre il 25% negli ultimi trenta anni). Dall’altro lato, la polarizzazione dei redditi aumenta i rischi di insolvenza dei debiti che sono all’origine della crescita della stessa base finanziaria e abbassa il livello mediano dei salari. Ne consegue che, sul lato della distribuzione del reddito, si apre una contraddizione che rende strutturalmente instabile il sistema economico. Inoltre i mercati finanziari, canalizzando in modo forzoso parti crescenti dei redditi di lavoro (Tfr e previdenza, oltre ai redditi che attraverso lo Stato sociale si traducono nelle istituzioni a tutela della salute e a favore dell’istruzione pubblica), sostituiscono lo Stato come fornitore di protezione sociale. Da questo punto di vista, essi favoriscono la privatizzazione del welfare state e della sfera della riproduzione sociale della vita. Esercitano quindi un biopotere. Infine, i mercati finanziari svolgono oggi la funzione di proxy della valorizzazione capitalista, cioè lo sfruttamento della cooperazione sociale e della rendita del general intellect. Sulla base di queste considerazioni, la sfera «reale» dell’economia (ovvero quella produttiva di lavoro e beni e servizi) non può essere distinta da quella finanziaria. Sono ormai del tutto interdipendenti.
È sul controllo dei mercati finanziari e su quale valuta debba svolgere il ruolo di riserva valutaria internazionale che oggi si gioca la partita geo-economica più rilevante. Negli anni Novanta, le tensioni geopolitiche si sviluppavano sul fronte del progresso tecnologico e del controllo dei diritti di proprietà tecnologica. Lo scontro riguardava sia i diritti e i brevetti sulle sementi e sulle biotecnologie di natura agricola che il controllo della generazione e diffusione della conoscenza nel campo industriale e soprattutto net terziario avanzato (i servizi di Internet). La predominanza del modello made in Usa delle catene di subfornitura internazionalizzata come ridefinizione degli assetti produttivi e della catena globale di lavoro comincia a entrare in crisi alla fine del millennio. Lo sfruttamento delle economie dinamiche di apprendimento (generazione di conoscenza) e di rete (diffusione di conoscenza) rappresentavano la base della capacità competitiva di un territorio e/o di una grande impresa conglomerata. Il dominio tecnologico statunitense inizia a declinare con l’ascesa dell’India e del Brasile nel campo delle biotecnologie agricole e della Cina nel manifatturiero e nell’innovazione tecnologica, soprattutto dopo l’entrata della Cina nel Wto nel 2001.
La competizione imperiale tra Usa e Cina e i grandi paesi emergenti come India, Russia, Brasile, Sud Africa si sposta così sul piano della logistica. Le nuove modalità di organizzazione sviluppatesi negli anni ’90 con la diffusione del capitalismo cognitivo si ristrutturano verso un nuovo modello di produzione a flussi che richiede un coordinamento sempre più complesso e preciso nel definire le catene del valore della subfornitura. Contemporaneamente, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relative alle merci e ai servizi acquistano un ruolo sempre più strategico. Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito al completo affrancamento della Cina dalla dipendenza tecnologica made in Usa. A partire dal 2008, la Cina diventa la più grande produttrice di brevetti tecnologici al mondo e comincia la conquista delle principali rotte di trasporto a livello globale, tramite politiche di penetrazione commerciale nel Sudamerica e soprattutto nell’Africa Centrale e Australe con la costruzione di grandi hub infrastrutturali come quello di Gibuti nel corno d’Africa. Non siamo più in presenza di un equilibrio unipolare, anche se instabile. Il processo di globalizzazione ha ridisegnato le forme della geopolitica tradizionale, così come era stata definita all’indomani del crollo del muro di Berlino e dell’accordo di Yalta nel dopoguerra. Come già intuito da Giovanni Arrighi, se il secolo XX è stato il secolo degli Usa, il secolo XXI rischia di essere il secolo cinese. Ma ciò avviene in un contesto multipolare. Dopo la perdita dell’egemonia tecnologica e logistica, gli Usa detengono ancora l’egemonia finanziaria. Ma fino a quando? La crisi dei subprime del 2007-2008 ha messo in discussione tale egemonia. Ma le eventuali crisi finanziarie che si possono verificare in modo sempre più ravvicinato non mettono in discussione il ruolo centrale dei mercati e della speculazione finanziaria: al limite, ridefiniscono il ruolo degli attori predominanti e delle borse.
Negli ultimi anni, abbiamo fronteggiato la crisi sindemica dettata dall’emergenza Covid-19 e oggi siamo in un periodo di guerra, che si preannuncia sempre più globale. Tali fattori di instabilità hanno favorito un’accelerazione di processi che erano già in corso, la platformization, ovvero lo sviluppo delle piattaforme e delle tecnologie di piattaforme che grazie alle nuove tecnologie e alle più recenti tecnologie, soprattutto nel campo telecomunicativo, pensiamo allo smartphone, all’iPhone, allo sviluppo degli algoritmi di prime di seconda generazione, hanno fatto sì che oggi qualsiasi atto della nostra vita viene intermediato, più o meno, da un app tecnologica. I periodi di lockdown hanno favorito questo processo, con una crescita dell’e-commerce di oltre il 100%. Tutte le volte che si creano momenti di incertezza, la speculazione finanziaria va a nozze. E i mercati finanziari ne hanno beneficiato dopo un primo momento di assestamento alla nuova situazione. Abbiamo assistito a un forte incremento degli indici di Borsa che hanno raggiunto i massimi nell’ottobre del 2021. L’indice Dow Jones ha superato la soglia psicologica dei 30.000 punti, l’indice Nasdaq ha superato quella dei 13.000. Nell’ultimo anno, l’emergenza Covid è stata sostituita dall’emergenza guerra. Si è però aggiunto un elemento nuovo. La ripresa economica mondiale post-covid ha intasato le vie della logistica con un forte aumento dei costi del trasporto e dei prezzi finali delle merci e dei servizi. Gli effetti della guerra Russia-Ucraina hanno paventato la possibile scarsità di gas per l’Europa di fronte al calo della fornitura da parte russa. Oggi sappiamo che tale scarsità non esiste nella realtà (in Italia, ad esempio, il gas disponibile eccede la domanda, al punto tale che l’Italia vende gas naturale all’estero: https://dgsaie.mise.gov.it/bilancio-gas-naturale) ma è stato sufficiente a ingenerare aspettative rialziste sul prezzo futuro del gas che sono state immediatamente attualizzate dei derivati future che vengono scambiati sul mercato TTF di Amsterdam. Il risultato è stato un forte aumento del prezzo del gas nel corso del 2022, un aumento che, tuttavia, era già cominciato nel 2021, ben prima dell’invasione russa in Ucraina. Conseguenza finale di tutto ciò è stata una ripresa dell’inflazione come non si vedeva da più di 20 anni. La reazione isterica delle Banche Centrali, in primo luogo la Fed americana, seguita dalla Bank of England e della BCE hanno portato ad un forte aumento dei tassi d’interessi, con effetto depressivo sui mercati borsistici. La ripresa degli indici azionari che aveva toccato i massimi a inizio 2022 (con il Dow Jones che superava i 35.000 punti e il Nasdaq oltre i 16.000 punti) si blocca e inizia un periodo di tendenziale caduta che si è accelerata negli ultimi mesi, proprio per l’aumento dei tassi d’interesse. L’aumento nel medio periodo dei valori di borsa ha prodotto una forte concentrazione nel capitalismo delle piattaforme: vi sono infatti cinque società negli Stati Uniti e altre cinque che ruotano nell’economia cinese che hanno raggiunto dei livelli di capitalizzazione impensabili. Si parla di 6,5 trilioni di dollari, cioè 6500 miliardi. Cinque sono già le famose GAFAM, un acronimo tratta dalle lettere iniziali di Google, Alphabet, Microsoft, Amazon, per quanto riguarda la Silicon Valley. In Cina, seppur con una capitalizzazione inferiore (circa 2000 miliardi), esiste l’acronimo BHATX, ovvero Baidu, Huawei, Ali Baba, Tencent, Xiao MI. Per dare un’idea dei valori assoluti e delle proporzioni, il valore di borsa delle GAFAM è pari alla somma della ricchezza del Pil generato da Italia e Spagna e Danimarca. Si tratta di una concentrazione finanziaria come mai si è visto nella storia del capitalismo. Tale esito è dipeso principalmente da due fattori.
Il primo fattore risale a più di 50 anni fa ed è il crollo del Sistema monetario di Bretton Woods. Dopo la dichiarazione di Nixon del 15 agosto 1971 che sanciva il venir meno della parità tra dollaro e oro (fissata convenzionalmente nel 1943 a Bretton Woods a 35$ per oncia d’oro), viene meno l’unità di misura della moneta. La moneta si smaterializza del tutto e diventa pura «moneta segno». Da quando è crollato il sistema di Bretton Woods, il valore della moneta diventa volatile e richiede una nuova regolazione. Avere una unità di misura, da cui dipendono i prezzi delle merci, i salari e tutte le altre variabili economiche, che si modifica continuamente crea forte instabilità e incertezza. È quello che è successo negli anni ‘70 con le varie crisi finanziarie e i tentativi di regolazione finanziaria e monetaria in Europa hanno preso la forma del Sistema Monetario Europeo sino ad arrivare alla costruzione dell’euro e agli accordi di Basilea. Tali processi sono stai accompagnati dalle politiche neoliberiste di deregolamentazione dei mercati finanziari, che hanno fortemente compromesso la governance degli stessi mercati finanziari di controllare la politica monetaria. È curioso ricordare che tutto ciò sia avvenuto nel momento stesso in cui si perorava in maniera del tutto strumentale e demagogica l’obiettivo dell’autonomia delle banche centrali. Nel momento stesso in cui, come sancito dall’articolo 105 del Trattato di Maastricht, la Banca centrale europea diventa autonoma rispetto al potere politico, essa – come le altre banche centrali, perde potere. La loro finalità di controllo della regolazione monetaria internazionale viene meno. Il cambio della regolazione monetaria, come diceva Marx, è la spia del mutamento dei rapporti sociali di potere, in quanto la moneta è essa stessa espressione di un rapporto sociale.
Il secondo fattore riguarda la definizione di un nuovo modello di regolazione monetaria e finanziaria, che ha sostituito Bretton Woods e la parità aurea di 35$ per oncia. Si tratta della creazione di convenzioni speculative. Il venir meno dell’autonomia nazionale e delle politiche di regolazione del sistema dei cambi ha dato un forte impulso al processo di finanziarizzazione: la transizione dalle tecnologie meccaniche ripetitive e statiche a quelle linguistico-relazionali dinamiche favorisce il passaggio dall’accumulazione materiale a quella intangibile. Tali processi sono stati favoriti dalla liberalizzazione delle transazioni finanziarie (sempre più virtuali, grazia alle ICT), esito di una precisa scelta politica neo-liberista. Tale liberalizzazione, lungi dal favorire un aumento della concorrenza (come ingenuamente o in mala fede si pensa), ha favorito un poderoso processo di concentrazione finanziaria, al punto che oggi, a partire dal 2005, una dozzina di grandi multinazionali della finanza e banche d’affari hanno il controllo di oltre l’80% dei derivati. Parimenti, nei mercati azionari, le strategie di fusione e acquisizione hanno ridotto in modo consistente il numero delle società quotate, in particolare nel capitalismo di piattaforma, ma anche nei settori più tradizionali, come quello dell’automotive. Da questi dati, possiamo arguire che in realtà i mercati finanziari non sono qualcosa di imparziale e neutrale, ma sono espressione di una precisa gerarchia: lungi dall’essere concorrenziali, essi nascondono una piramide, che vede, al vertice, pochi operatori finanziari in grado di controllare oltre il 65% dei flussi finanziari globali e, alla base, una miriade di piccoli risparmiatori e operatori finanziari che svolgono una funzione passiva. Tale struttura di mercato consente che poche società (in particolare le dieci citate in precedenza) siano in grado di indirizzare e condizionare le dinamiche di mercato. Ed è proprio tale potere gerarchico a dare la possibilità all’oligarchia finanziaria dominante di generare «valore» tramite lo sviluppo di «convenzioni» (bolle speculative) in grado di creare aspettative tendenzialmente omogenee che spingono i principali operatori finanziari a puntare su alcuni tipi di attività finanziarie. Negli anni ’90 è stata la Internet Economy, negli anni 2000 l’attrazione è venuta dallo sviluppo dei mercati asiatici (con la Cina che entra nel Wto nel dicembre 2001) e dalla proprietà immobiliare. Gli effetti devastanti del crollo della bolla immobiliare nel 2008 hanno reso necessario un forte intervento degli Stati per tappare le falle di bilancio apertesi nelle grandi istituzioni bancarie, assicurative e finanziarie. Lo Stato ha svolto così il ruolo di prestatore d’ultima istanza, quindi a fondo perduto e senza effetti di stimolo sulla domanda. L’imposizione delle politiche di austerity, soprattutto in Europa con il corollario di smantellamento e privatizzazione dello stato sociale e di precarizzazione del lavoro e dei redditi, ha favorito il sorgere di una nuova convenzione, che potremmo definire «convenzione welfare», dove oggetto della stessa speculazione è direttamente il benessere (il bios) degli individui. Il biopotere della finanza si conferma pervasivo e sempre più diretto. Le tensioni geo-politiche attuali hanno anche come origine il tentativo di definire nuove convenzioni speculative dominanti in grado di sganciarsi dall’egemonia del dollaro. È in corso una battaglia valutaria, in particolare tra Usa e Cina che si gioca sul terreno dell’Europa. Le sanzioni dei paesi Nato (Turchia esclusa), e non solo, sono la risposta di guerra economica all’invasione dell’esercito russo ai danni dell’Ucraina. Oltre a colpire il settore energetico, i trasporti, il commercio e la ricchezza privata di numerosi individui legati al governo di Mosca, la strategia sembra quella di estromettere la Russia dal sistema dei pagamenti internazionali. Lo strumento principale è il sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), che regola i pagamenti transfrontalieri che passano per il sistema bancario. Gli ordini di pagamento sono trasmessi tramite un consorzio internazionale di banche con sede in Belgio che collega attraverso una rete informatica circa 11.000 istituzioni finanziarie in tutto il mondo. SWIFT fu costituito nel 1977 per evitare che l’infrastruttura dei pagamenti internazionali fosse monopolizzata dall’americana Citibank. Per una ironia della storia, ha finito per diventare la principale arma degli Stati Uniti nell’esercizio dell’egemonia monetaria globale. La prima volta che il sistema dei pagamenti viene utilizzato per fini militari e strategici è stato nel 2012 quando, sotto la pressione americana, SWIFT ha disconnesso il sistema bancario dell’Iran nel quadro del pacchetto di sanzioni impiegato per fermarne il programma nucleare. Il sistema dei pagamenti si è rivelato immediatamente uno strumento bellico estremamente efficace per garantire l’attuazione delle sanzioni. Infatti, è sufficiente sospendere il codice SWIFT di un individuo, di un’impresa o anche di un intero Paese per impedire a chiunque (compresi gli intermediari) di effettuare pagamenti verso il beneficiario identificato da quel codice.
Queste sanzioni finanziarie, quando sono comminate dagli Stati Uniti, possono avere effetti ancor più devastanti di un attacco militare. Sono «un’arma nucleare», come ha commentato recentemente un banchiere occidentale.
Il paragone non è azzardato: infatti, al pari di un attacco atomico, seppure in maniera diversa, più lenta e più subdola, le sanzioni rischiano di provocare ripercussioni devastanti anche per chi le mette in atto, minando alla radice l’egemonia monetaria del dollaro. Le sanzioni economiche hanno l’obiettivo di depotenziare l’economia russa, sino a causare una recessione economica. Già a partire dal 2014, dopo l’annessione unilaterale della Crimea da parte di Mosca, le potenze occidentali, in primis gli Usa, avevano imposto sanzioni all’economia russa, così come, pur se in maniera diversa, era stato deciso da Trump nei confronti dell’Iran nel 2018 per la questione nucleare. In questo caso, secondo i dati FMI, il Pil iraniano è calato del 5% nel 2020. Ma per la Russia la situazione appare diversa, grazie alla maggior indipendenza e autarchia della sua economia. Putin ha dichiarato a fine 2019 che le perdite causate dalle sanzioni all’economia russa erano inferiori a 50 miliardi di dollari. Uno studio ha stimato una mancata crescita del Pil tra lo 0,5% e l’1,5%, per una perdita complessiva fra 40 e 120 miliardi di dollari dal 2014 al 2018. Il lato debole dell’economia russa è la sua “dollarizzazione”, vista l’ingente quantità di valuta americana che entra nel paese a causa dell’elevato export di materie prime quotate in dollari (gas e petrolio, ma non solo). Se questi dati vengono confermati, l’impatto è tutto sommato limitato. Ma queste sanzioni contengono delle novità importanti, soprattutto sul lato finanziario. Infatti, oltre al già ricordato blocco del sistema Swift per alcune banche (escluse quelle che intermediano i prodotti energetici), si prevede anche il congelamento delle riserve valutarie della Banca Centrale. Si tratta di un provvedimento che gli Usa avevano già intrapreso nei confronti di Iran, Venezuela e Corea del Nord ma che oggi per la prima volta viene usata nei confronti di un paese del G20, detentore di grandi riserve. Secondo i dati della Banca Centrale Russa, al 31 gennaio 2022, le riserve valutarie russe ammontano a oltre 630 miliardi di dollari (630,207, per l’esattezza), di cui circa 500 in valuta estera e 130 in oro, per un totale di 2300 tonnellate d’oro, circa un terzo degli USA, due terzi della Germania e poco meno di Francia e Italia. Si tratta di un ammontare che è cresciuto costantemente nel tempo, a partire da metà 2015 (poco più di 350 miliardi di dollari all’epoca), a seguito di una precisa strategia di Putin di creare una sorta di scudo per affrontare gli effetti recessivi delle sanzioni occidentali a seguito dell’annessione della Crimea. Contemporaneamente, la Banca di Russia ha venduto tutti i suoi titoli di stato americani fra aprile e maggio del 2018, nel tentativo di mettere le proprie riserve al riparo dagli Stati Uniti nel caso di un inasprimento delle relazioni. Tuttavia, nonostante il tentativo di «de-dollarizzare» l’economia e le riserve valutarie, il 60% di tali riserve è detenuto ancora in dollari, escludendo una quota del 13% detenuto in valuta cinese (quota destinata ad aumentare). L’impatto immediato delle sanzioni, più ancora del parziale blocco dello SWIFT, è l’impossibilità per la Banca Centrale russa di poter vendere parte delle proprie riserve per sostenere il corso del rublo, che, non casualmente, ha perso circa il 30% nel giorno in cui le sanzioni sono diventate operative. È questo il rischio maggiore che può correre l’economia russa. Dopo questo iniziale tracollo (il cambio rublo/dollaro è passato da 82 rubli per un dollaro del 24 febbraio, giorno di inizio dell’invasione russa, a 152 rubli per dollaro il 7 marzo), attualmente il rublo viene quotato su valori intorno a 65 rubli per dollaro e il suo valore si sta stabilizzando. La svalutazione rispetto all’euro è inferiore, visto che l’euro in questo periodo si è svalutato rispetto al dollaro. I dati ci dicono che le sanzioni, dopo un iniziale pesante effetto, si stanno rivelando meno efficaci del previsto, probabilmente anche in seguito al ricorso di valute alternative non direttamente legate al dollaro (quindi non bloccabili) come la valuta cinese e le criptomonete. Le dichiarazioni di Putin del 23 marzo 2022 di continuare la fornitura di gas all’Europa, mantenendo fede ai contratti in essere, convertendo la valuta di pagamento da dollari in rubli, se da un lato intende proseguire sul processo di «de-dollarizzazione», dall’altro intende confermare la tenuta della stessa valuta russa. Il blocco delle riserve valutarie russe costituisce un precedente che rischia di ripercuotersi sullo status del dollaro come moneta internazionale: che strumento di riserva può mai essere quello che rischia di venire a mancare proprio nel momento del bisogno? Questo precedente potrebbe ridurre la disponibilità di altri Paesi, in particolare della Cina, a detenere le proprie riserve sotto forma di titoli del Tesoro americano e, in generale, titoli denominati in dollari, indebolendo la funzione del dollaro come strumento di riserva internazionale. Come anticipato da Giovanni Arrighi in «Adam Smith a Pechino», il nuovo secolo si prefigura come il «secolo cinese» in grado di sostituire il XX secolo come «secolo americano». L’illusione statunitense di rimanere l’unica potenza egemone una volta crollata l’URSS si perde di fronte al crescente potere economico e tecnologico cinese. Gli Usa cercano di mantenere il potere militare, finanziario e mediatico (il quarto potere di Orson Welles) al fine di compensare il declino dell’egemonia economica. Il potere militare è il primo a cominciare a declinare proprio perché non adeguatamente surrogato da quello economico. Il tentativo di ripristinare l’autorevolezza USA del proprio raggio d’azione ha al momento successo per quanto riguarda l’Europa, sulla quale è strategico mantenere un’influenza ideologica e commerciale. Ma si tratta di un Europa che non è capace e non vuole diventare economicamente e politicamente autonoma rispetto alla sfera di influenza Usa, che ha tutto l’interesse a un’Europa sotto controllo e impotente, anche a costo di mettere a repentaglio quel poco di potere finanziario che ancora oggi il dollaro detiene. Siamo quindi in una finanza di guerra. L’unico sistema è sedersi ad un tavolo e ripensare una nuova Bretton-Woods, questa volta non più basata sull’egemonia Usa ma tesa a costruzione una governance monetaria e finanziaria multipolare. Tutti ne avrebbero da guadagnare con l’esclusione degli Usa che vedrebbero venir meno la possibilità di farsi finanziare dal commercio internazionale il proprio debito estero e quello interno. L’economia Usa, infatti, è caratterizzata da un deficit strutturale nella bilancia commerciale, a cui si è aggiunto negli ultimi anni un incremento del deficit pubblico anche a causa dei provvedimenti anti Covid. L’unica possibilità è avere un avanzo nei movimenti dei capitali grazie all’egemonia sui mercati di borsa e alla tenuta del dollaro come moneta di riserva globale. Una nuova Bretton Woods multipolare non potrebbe basarsi più su tale ruolo del dollaro e ciò spiega perché gli Usa (tramite lo strumento Nato e l’acquiescenza suicida dei paesi europei) siano i più interessati al prolungamento della guerra in Europa, non solo perché un’economia di guerra è sempre utile agli apparati industriali e al capitalismo delle piattaforme ma perché consentirebbe all’economia Usa di far pagare i propri debiti al resto del mondo. Ma come abbiamo visto, la situazione appare complessa e fluida perché le armi della finanza di guerra possono ritorcersi contro agli stessi utilizzatori.
Passiamo al tema dell’inflazione. Si dice che la pandemia prima e la guerra poi siano le cause dell’inflazione. La FED si è già mossa, e la BCE ha preannunciato che a breve aumenteranno i tassi d’interesse. La cosa che volevo chiederti è come facciamo ad uscire da questa «trappola monetarista» per cui l’unico modo di combattere l’inflazione è quello di aumentare i tassi, mettendo in moto dinamiche recessive. Cos’altro si potrebbe fare? Noi sappiamo che la parola d’ordine classica dei movimenti, che oggi andrebbe ripresa, è quella della scala mobile. Ciò significherebbe che l’unico vero problema in una logica antagonista sarebbe quello della difesa del potere d’acquisto. Cosa puoi dirci in proposito?
La costruzione della moneta unica in Europa, sancita dal Trattato di Maastricht del dicembre 1991, si basa sull’assunto di un legame diretto tra offerta di moneta e livello dei prezzi e ha come unico obiettivo il controllo del tasso d’inflazione (2%). La perdita di autonomia economica delle Banche Centrali, come abbiamo già sottolineato, influenza pesantemente le scelte di politica monetaria, sempre meno orientate alla crescita e all’occupazione ma sempre più condizionate dalle dinamiche speculative dei mercati finanziari e dalla loro instabilità. Di fatto, l’unico strumento a disposizione delle autorità monetarie è oggi la fissazione dei tassi d’interesse in funzione delle aspettative speculative. La dinamica dei tassi d’interesse è oggi una spia del tipo di aspettative che operano sui mercati finanziari. Se siamo in presenza di aspettative positive, i tassi di interesse e i rendimenti sui titoli tendono a scendere a fronte di un aumento degli indici di borsa e delle relative plusvalenze, e viceversa. Si tratta della politica monetaria che, non a caso, è stata perseguita negli Usa all’indomani della crisi dei subprime del 2007-08 e in Europa dopo la crisi dei debiti sovrani del 2011. Le politiche di Quantitative Easing (QE) avevano, ufficialmente, due obiettivi: tenere i tassi d’interessi sul debito pubblico sufficientemente bassi e favorire l’erogazione di credito all’economia reale per sostenere la crescita economica. Se il primo obiettivo è stato raggiunto, il secondo è stato un totale fallimento, dal momento che, come era facilmente prevedibile, l’ammontare di liquidità creata a partire dal 2015 (pari a circa a 2.900 miliardi di euro, il 20% del Pil europeo), lungi dal favorire gli investimenti, è stata invece una manna per i mercati finanziari a vantaggio, soprattutto, dell’attività speculativa: in altre parole, si sono alimentati i mercati finanziari in quanto motore del processo di accumulazione e valorizzazione contemporaneo. I falchi dell’austerity, soprattutto in Europa, paventavano che in tal modo si rischiasse di innescare un processo inflazionistico, come quello che si era verificato durante la crisi fordista degli anni Settanta. Si tratta di un’obiezione del tutto fallace: oggi la moneta creata ex nihilo con l’acquisto di titoli di stato è pura moneta-segno, del tutto smaterializzata. Il suo legame con la produzione reale è oramai inesistente, grazie proprio al ruolo assunto dai mercati finanziari, il vero ambito in cui si crea (e si distrugge) moneta. La teoria quantitativa della moneta (che definisce un rapporto tra crescita dell’offerta di moneta e aumento dei prezzi quando la produzione si avvicina alla sua massima capacità) oggi non ha più senso all’interno dei processi di valorizzazione bio-cognitiva e delle piattaforme. Lo dimostra il fatto che l’enorme ammontare di liquidità immesso sui mercati creditizi e finanziari abbia inciso sul tasso d’inflazione solo per lo 0,5%, al punto che sino a un anno fa il tasso d’inflazione europeo era al di sotto dell’obiettivo programmato del 2%. Si potrebbe ora dire che la recente impennata dei prezzi pone una situazione del tutto nuova. Ma quali son le cause che hanno portato all’aumento del tasso di inflazione? Si tratta di una discussione aperta ma di una cosa possiamo essere certi: la responsabilità non è della politica monetaria espansiva del QE. Nel contesto che abbiamo descritto, non vi è più un legame diretto tra quantità di moneta e livello dei prezzi. Di conseguenza, una politica monetaria restrittiva, che via aumento dei tassi d’interessi, riduca la liquidità in circolazione per ridurre l’incremento dei prezzi rischia di avere come unico risultato quello di favorire una spirale recessiva. Si tratterebbe di una situazione deleteria proprio in una congiuntura che vede la dinamica del Pil rallentare a livello globale a causa delle tensioni geopolitiche in corso. Ciò vale a prescindere dal fatto che l’inflazione sia più causata da variabili di domanda (come pare essere negli Usa) che da variabili di offerta (come è invece nel caso europeo e italiano). Negli Usa, il tasso di inflazione ha raggiunto livelli che non si vedevano da quaranta anni e sicuramente tale dato è influenzato, oltre che dall’incremento dei prezzi delle materie prime (in fase di rallentamento) e dall’aumento dei costi della logistica, anche dall’aumento della domanda. È il risultato della ripresa americana dopo il periodo di lock-down seguito alla sindemia da Covid-19. Ed è proprio, l’influenza della crescita della domanda a spiegare il perché l’inflazione Usa è di 2 punti percentuali superiore a quella europea. Ciò significa che la stretta della FED sui tassi d’interesse sarà in grado di ridurre l’inflazione solo in modo molto parziale. Il fatto che il prezzo del petrolio e del gas metano aumentasse era dato per scontato dopo il forte ribasso a seguito degli effetti recessivi dovuto alla sindemia da Covid-19. Di fronte alla forte ripresa della domanda globale (soprattutto in Cina e negli Usa), la crescita della conseguente domanda di materie prime ha trainato l’aumento dei prezzi, anche per effetto di due fattori concomitanti: lo sviluppo di tensioni speculative sui prodotti derivati «future» energetici (in particolare gas), con l’esito di anticipare all’oggi attese future sull’aumento dei prezzi, e le difficoltà di approvvigionamento dei beni intermedi in seguito alle strozzature della catena internazionale di subfornitura, che ha penalizzato e rallentato l’offerta dei beni finali ma ne ha aumentato il costo di produzione. A differenza degli anni Settanta, l’aumento dei prezzi è infatti avvenuto in assenza di un aumento dei salari e del costo del lavoro. Relativamente all’Italia, i dati Istat del primo trimestre 2022 sulla dinamica del mercato del lavoro, ci dicono che «su base annua il costo del lavoro si riduce dello 0,2%, per effetto della riduzione di entrambe le sue componenti (-0,2% le retribuzioni e -0,4% gli oneri sociali)». In molti settori, l’aumento dei prezzi non è causato da incrementi di costi di produzione (se non in maniera contenuta) ma esclusivamente dall’aumento del margine di guadagno (mark-up). Siamo cioè in presenza di un’inflazione da profitto. Da questo punto di vista, una politica monetaria restrittiva sarebbe del tutto inefficace e avrebbe l’effetto di buttare benzina sul fuoco, senza intervenire sulle vere cause dell’inflazione, e, ancora una volta, finirebbe per essere di sostegno alla profittabilità del sistema delle grandi imprese. Se la situazione bellica in atto porta ad un processo di trasformazione della biopolitica in necropolitica, altrettanto si può dire dell’economia: dalla bio-economia alla necroeconomia. È necessaria una politica economica del tutto opposta, che intervenga sul lato della domanda e del sostegno ai redditi da lavoro congiuntamente con una politica fiscale che sia in grado di distribuire in modo più equo il reddito. Tutto ciò dovrebbe essere accompagnato da interventi di regolazione sui mercati delle materie prime, in primo luogo separando l’attività speculativa da quella reale derivante dall’incrocio tra domanda e offerta.
Andrea Fumagalli è docente di economia all’Università di Pavia. È stato fondatore della rivista «Altreragioni». Con Sergio Bologna ha curato Il lavoro autonomo di seconda generazione (Feltrinelli, 1997). Altri suoi lavori sono: Bioeconomia e capitalismo cognitivo (Carocci, 2007) e La moneta nell’impero (insieme a Christian Marazzi e Adelino Zanini, ombre corte, 2002). Per DeriveApprodi ha pubblicato Economia politica del comune (2017) e Valore, moneta, tecnologia (2021).
Antonio Minaldi impegnato nei movimenti fin dal ’68. Esponente del movimento studentesco del ’77. È tra i fondatori dei Cobas scuola nel 1987. È stato docente di filosofia e storia nei licei. È autore di vari saggi di economia e di filosofia.